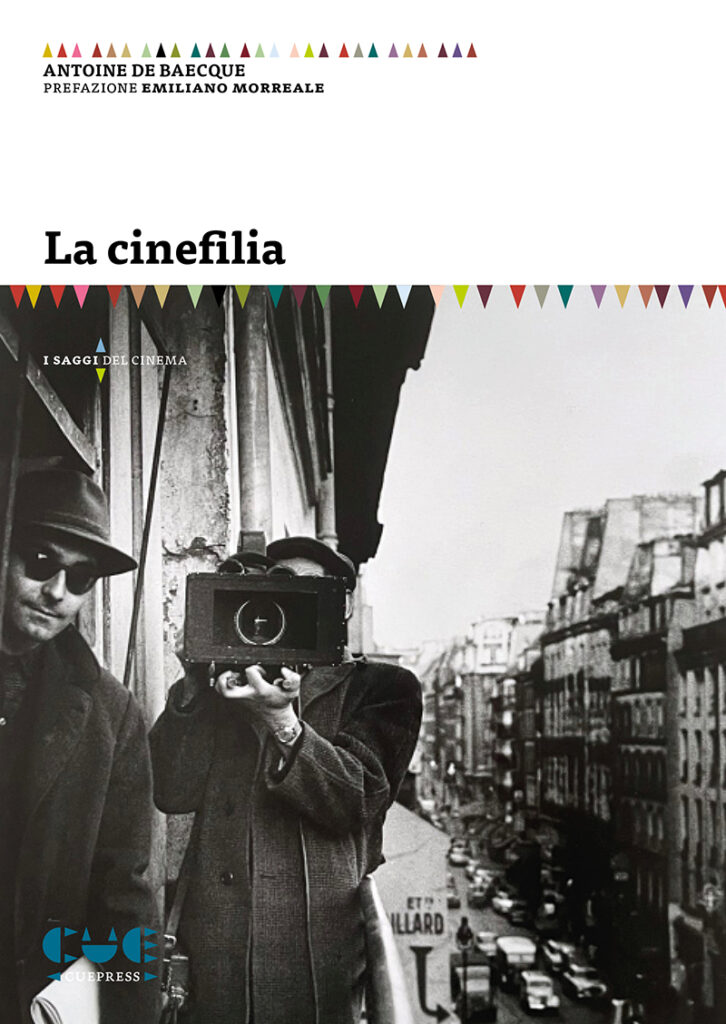La politique des cinéphiles
Roy Menarini, «Fata Morgana Web»
La cinefilia. Invenzione di uno sguardo, storia di una cultura 1944-68 di Antoine De Baecque.
La prima affermazione implicita del volume La cinefilia. Invenzione di uno sguardo, storia di una cultura 1944-68 (finalmente tradotto in Italia da CuePress, dopo l’uscita originaria del 2004, con la consulenza e la prefazione di Emiliano Morreale) è che la cinefilia è un fatto francese. Questa affermazione, intorno alla quale per tanti anni ci si è trovati d’accordo, appare oggi meno scontata. Mentre la critica cinefila – e la nascita della critica moderna, che significa quasi la stessa cosa – è di certo un esperimento parigino, la cinefilia in generale potrebbe avere altre madri e altri padri, dalla cultura cinematografica italiana degli anni trenta alla Hollywood degli anni quaranta. Tutto sta a decidere che cosa sia la cinefilia, questione assai problematica, che per di più poggia su fonti effimere e instabili – la cinefilia è una pratica, non una teoria né un settore della scrittura editoriale, e come tale spesso è singolare, solipsistica, comportamentale.
De Baecque, invece, è uno storico che desidera interrogare le fonti (ha lavorato su Robespierre, la Rivoluzione Francese, il Terrore) e dunque immagina la cinefilia come un prodotto originale di un’epoca (il secondo dopoguerra) di cui si può ricostruire la fisionomia a partire dai documenti – che sono principalmente riviste e quotidiani, ma anche epistolari, memorie, programmi, paratesti e così via. Ovviamente va bene così, e nel caso francese è più che giusto, perché la gigantesca battaglia culturale che va dalla fine della Seconda guerra mondiale al 1968 (date sufficientemente evocative per non dover essere giustificate) non si limita a una nicchia per appassionati ma assume connotati politici, sociali e istituzionali molto forti.
Come spiega Morreale,
La storia della cinefilia è anche un capitolo del rapporto tra Europa e Stati Uniti, di un’immagine degli Stati Uniti che, a partire da un gruppo piccolo e minoritario di intellettuali francesi, viene restituito di là dall’Oceano a costituire un’autorappresentazione da parte di una generazione di critici e registi (senza la politique des auteurs non sarebbe quella prima generazione di registi cinefili che dà l’assalto a Hollywood dalla fine degli anni Sessanta, da Scorsese a Spielberg…).
In effetti, l’alleanza tra la cinefilia dei Giovani Turchi, e poi dei radicalissimi MacMahonisti, con Hollywood va oltre l’apprezzamento estetico e la rivolta contro il contenutismo della critica comunista ortodossa, e diventa anche strategia industriale.
L’anti-comunismo dei «Cahiers» del periodo giallo è conclamato e si sviluppa principalmente a partire dal 1954 in poi, con l’influenza sempre più marcata di Truffaut e Godard. Dentro alla rivista, mostra De Baecque (autore anche di una storia dei «Cahiers» altrettanto appassionante, Assalto al cinema), vivono tante anime, da quella cattolica di Bazin a quelle più vicine alla cultura ufficiale di Sartre. Ma è proprio uscendo dalle pur avventurose vicende dei «Cahiers» (con la battaglia di Rohmer e poi contro Rohmer, con la contraddittoria risposta alla Nouvelle Vague, con la politicizzazione di metà anni sessanta), che La cinefilia prende il volo. È nella minuziosa ricostruzione della cosmogonia di riviste e bollettini, di terze pagine dei quotidiani e di dibattiti pubblici, di frequentazioni poco note (Truffaut con i collaborazionisti) e di firme meno celebrate (in primis Bernard Dort) che il volume entusiasma e stupisce.
Si ricostruisce, infatti, una rete fittissima di riferimenti, che da una parte toccano e rispecchiano il vertice dell’iceberg di una cultura istituzionale in rapido mutamento e attraversata da spinte centrifughe che stanno modellando il presente e il futuro della liberal-democrazia post-coloniale transalpina; dall’altra allargano lo sguardo a tal punto da diventare centrifughi (basti pensare alle derive cineclubbarie e cultuali, peraltro adorabili, raccontate da Jacques Thorens nel celebre volume Il Brady, 2017).
È una vicenda frastagliata, dove – oltre alla storia editoriale – è lecito seguire anche la storia delle idee, la storia della ricezione dei film e la storia degli autori. In questo scenario, giustamente De Baecque offre molto spazio a «Positif», relegata da molti appassionati superficiali al ruolo di anti-Cahiers paludato e trotzkista, mentre anch’essa era attraversata da ogni genere di approccio. E in ogni caso, senza «Positif» un altro cinema americano (da Huston a Tashlin, da Aldrich a Losey) avrebbe rischiato di fare la stessa fine del fattore H (Hitchcock/Hawks) prima dei «Cahiers».
E, se si pensa che manchi uno sguardo sull’elefante nella stanza (ovvero il maschilismo escludente impietoso di tutta questa romantica avventura critica), De Baecque risponde. C’è un capitolo impagabile dedicato all’erotomania dei critici francesi. Il fatto è semplice: il trasporto metafisico per l’immagine schermica, che deriva dal formalismo della «mise en scène» e della sua esaltazione, si traduce in una sensualità diffusa verso i corpi delle attrici – essendo buona parte della cinefilia popolata da critici maschi eterosessuali. Dunque, le liste redatte da Truffaut e altri dedicate alle movenze, ai dettagli curvilinei, alle pieghe carnali delle dive hollywoodiane ed europee – oggi apparentemente irricevibili – appaiono all’epoca come un ulteriore capitolo della strategia discorsiva di una vera e propria rivoluzione estetica e teorica.
In conclusione, anche se De Baecque lo suggerisce solo in parte (più interessato a mantenere equidistanza e a costruire pian piano il puzzle culturale), La cinefilia ci ricorda anche quanto il mondo degli studi accademici sul cinema debba a questa pratica così originale e inventiva. Il paradosso è che, più la cinefilia appare a distanza di anni esagerata, mistica, partigiana, visionaria, più in verità alzava l’asticella del sapere: richiedeva conoscenza appropriata, precisione filmografica, competenza storiografica, disciplina spettatoriale, in disprezzo di ogni dilettantismo pour parler (che dura lezione dev’essere leggere questo volume per certi sedicenti cinefili da social media; ma utile a una rieducazione mai troppo tardiva). Inoltre si possono aggiungere: apertura alle teorie dell’autore, attenzione alla teoria della recitazione e della performance, analisi del film, metamorfosi della nozione di stile, e molto altro ancora, tra cui la filosofia del cinema in tutte le sue forme (compreso Deleuze, notoriamente debitore della cinefilia canonica dei «Cahiers» per la stesura di L’immagine-movimento e L’immagine-tempo). Vittime, invece, della filosofia dello ‘sguardo’ sono stati per lungo tempo la sceneggiatura, la produzione, l’audience. Ma il tempo ha poi riequilibrato l’orizzonte.
Riferimenti bibliografici
A. de Baecque, Assalto al cinema. La storia dei Cahiers du Cinéma, Il Saggiatore, Milano 1993.
J. Thorens, Il Brady, L’Orma, Roma 2017.
Collegamenti