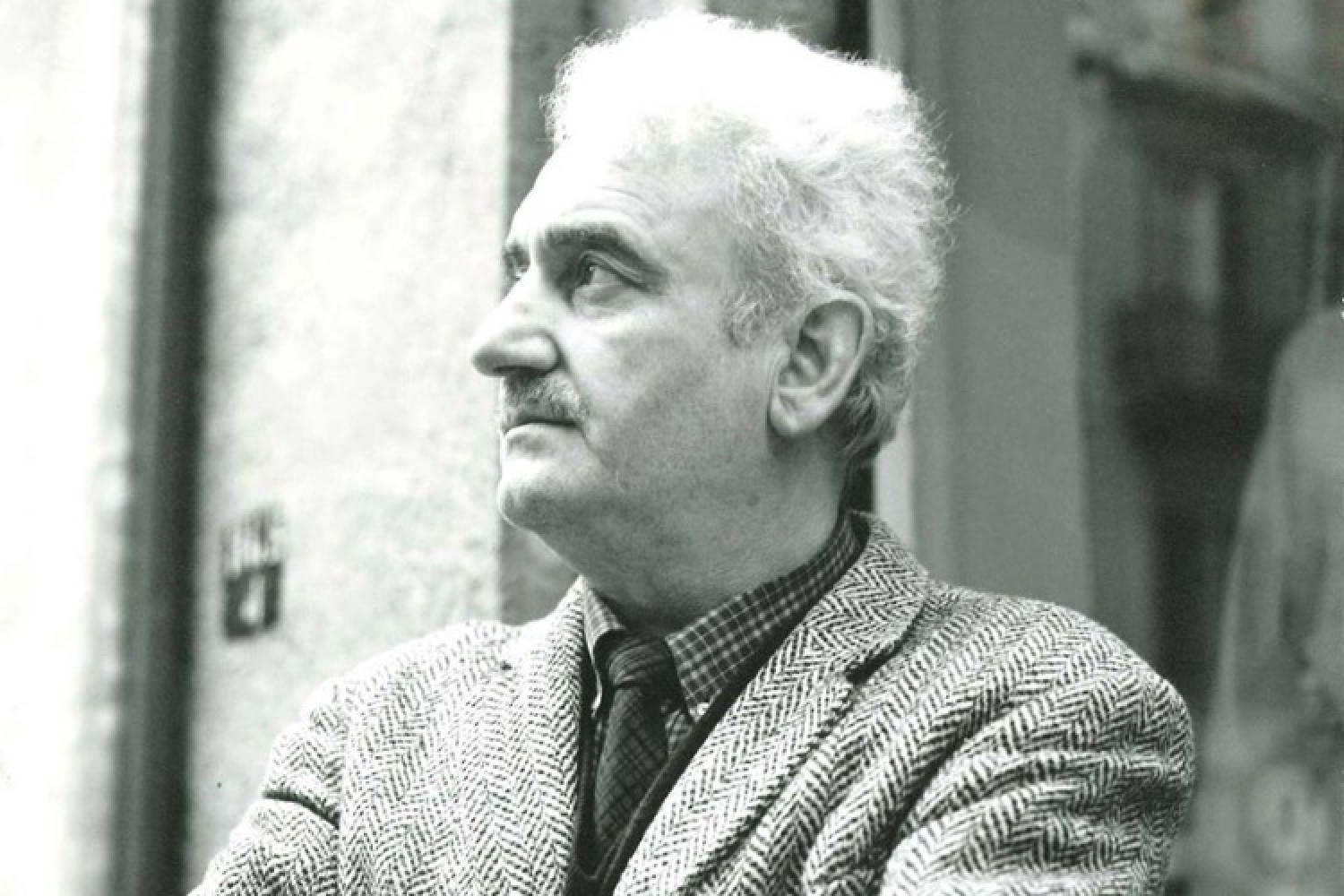Logbook
Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

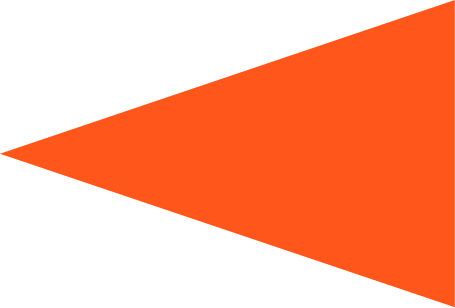
Barabba. In scena l’opera di Tarantino a metà strada tra commedia e tragedia
Al Nest – Napoli Est Teatro – il 21 e 22 gennaio va in scena Barabba di Antonio Tarantino, esponente della drammaturgia contemporanea. Ombroso e solitario, ma anche poliedrico e innovativo, Tarantino è scomparso a ottantadue anni nel 2020 ed è autore di vari testi teatrali, tutti scritti in età matura dopo una lunga esperienza come artista figurativo.
Nella sala partenopea – allestita con quasi cento posti in una scuola abbandonata – la stagione 2022-2023 è stata denominata Vieni a scoprire i nostri assi, e non è dunque casuale la scelta di Tarantino tra gli autori rappresentati, così come non lo è quella dell’opera, composta nel 2010 ma rimasta inedita fino alla pubblicazione postuma nel 2021 per le edizioni Cue Press e la prefazione di Andrea Porcheddu.
Lo spettacolo, interpretato da Michele Schiano di Cola con allestimenti e luci di Vincent Longuemare, è diretto da Teresa Ludovico, che già in passato ha rappresentato altri rilevanti testi del Maestro come La casa di Ramallah, Namur, Cara Medea e Piccola Antigone. Tutti accomunati da personaggi che – come la stessa regista ha dichiarato – sono «portatori di mitiche ferite, chiedono all’attore di essere incarnati così come si presentano: nudi e crudi, senza nessun giudizio», e dei quali spicca soprattutto «la voce, magari rauca, di quell’umanità che ha paura dell’altro, che si sente continuamente minacciata e che vive di doppiezza».
In Barabba però Tarantino, come nei drammi d’esordio – tra cui il monologo Stabat Mater e i testi della cosiddetta Tetralogia delle Cure – riporta sul palcoscenico un personaggio evangelico, rendendolo protagonista di un’opera quasi integralmente in versi e a metà strada tra commedia e tragedia, facendo emergere con tutta la sua forza l’anima tormentata del protagonista come tramandato dalla tradizione dei quattro vangeli canonici, che lo identificano già dal suo nome come letteralmente «Figlio del Padre» o «Gesù Barabba».
Ebreo detenuto dai Romani a Gerusalemme assieme ad alcuni ribelli e negli stessi giorni della passione di Cristo, Barabba, com’è noto, venne liberato da Ponzio Pilato per volontà del popolo, chiamato a scegliere chi rilasciare tra lui e Gesù di Nazareth, trovandosi così a vivere un dramma personale che diventa poi dramma collettivo e fatto storico.
Nel suo teatro di emozioni e di pathos, fondato sulla forza dirompente della parola e del linguaggio spesso crudo e contemporaneo, Tarantino tratteggia in maniera netta la storia di un uomo solo, che si snoda in uno spazio chiuso ma che al tempo stesso è il riflesso dell’esterno e delle vicissitudini di tutta l’umanità. Barabba, isolato nella sua cella, si trova infatti ad essere involontario testimone della condanna e del martirio di Gesù, anch’egli Figlio del Padre, e si interroga allora alla ricerca di una verità superiore ed evidentemente distante da quella terrena, talvolta ingannevole, che si concretizzerà difatti in forme diverse: nella crocifissione dell’uno e nella salvezza dell’altro. Lo stesso nome, ma due destini opposti.
Barabba si tormenta nel suo meditare rabbioso e incontrollato finché Cristo, pur essendo in procinto di morire sulla croce, impartisce la benedizione urbis et orbis. Comprenderà così solo allora che la verità divina non conosce alcuna contraddizione ed è talmente avulsa dalle miserie terrene da sembrare persino folle, potendo così finalmente raggiungere la fede e la serenità:
«Se lui mi ha assicurato che me la caverò allora vuol dire che ci devo credere perché è venuto qualcuno che mi ha voluto bene. Roba da matti».
Gigi Giacobbe, Bob Wilson in Italia
Mancava un libro dedicato allo spettacolo di Bob Wilson capace di darne ampia visibilità divulgativa, in aggiunta agli interventi critici di sapore specialistico e accademico. La lacuna è colmata da questo lavoro, agile e assai interessante, di Gigi Giacobbe, che ricostruisce gli allestimenti di Bob Wilson in Italia realizzati dal 1994 al 2022.
Dichiara il regista texano: «Il Teatro? È la somma di tutte le arti». In questa idea di teatro totale si incontrano e coesistono il movimento del corpo, la parola, la luce, il suono, le immagini, disponendosi e interagendo su un piano narrativo che supera la centralità del testo letterario per trasportare lo spettatore in una dimensione di incanto atemporale in un universo di bizzarra fantasia. In merito all’alchimia dei colori e dei movimenti coreografici dei suoi spettacoli, Wilson sottolinea che l’attore in scena «è estremamente formale, non deve essere spontaneo, deve essere immediatamente riconoscibile in quanto movimento artificiale creato per il teatro». Altri e simili intenti d’arte, basilari per inquadrare la ricerca sperimentale condotta da questo straordinario regista, tra i maggiori e innovativi della scena mondiale contemporanea, si leggono nella prima parte del volume di Giacobbe.
Dal discorso teorico si passa alla verifica della sua materializzazione sul palcoscenico attraverso l’occhio critico di osservatori eccellenti. Achille Bonito Oliva riconosce nella struttura del Teatro–totale–immagine l’architettura creativa di uno «smontaggio, di un’atomizzazione del gesto» definito nel rallentamento e nella ripetizione, talvolta con effetti dilatati, dell’azione dell’attore, secondo uno schema che in parte rinvia alle suggestioni esercitate dal Teatro Nō giapponese o si avvicina alle composizioni musicali di John Cage.
Il sipario sullo spettacolo wilsoniano Giacobbe lo apre accorpando, in ordine cronologico, le sue stesse recensioni, scritte con competenza e minuzia critica. È come entrare nel mondo delle meraviglie, a partire dall’iniziale Alice del 1994 e da Hamlet a monologue, presentato alla Biennale Teatro di Venezia nel 1995, interpretato dallo stesso Wilson in uno spazio scenico che si colorava di azzurro e di rosso. Oppure Woyzeck di Georg Büchner visto a RomaEuropaFestival nel 2002 e «recitato e cantato da formidabili attori-cantanti danesi», sottolinea Giacobbe, che poi ricorda la magistrale prova di Adriana Asti nel beckettiano Giorni felici al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2009. Alle spalle dell’attrice, con il «viso bianchissimo interrotto dal rosso del rossetto e dal suo generoso decolleté su un vestito grigio-azzurro», c’è un fondale bianco accecante e interrotto talvolta da effetti azzurri e rosa.
Se memorabili rimangono I Sonetti di Shakespeare allestiti ancora a Spoleto nel 2010, altrettanto vale per Lulu di Wedekind, accompagnata dalle musiche di Lou Reed, con la protagonista caratterizzata da «immutabile, […] faccia infarinata e pesante trucco», come se fosse sul set di un film in bianco e nero.
Altro spettacolo-manifesto della cifra stilistica di Wilson è Odyssey al Piccolo Teatro di Milano nel 2013: è un susseguirsi di magie illuminotecniche che avvolgono i personaggi omerici calati in un ambiente scenografico e sonoro in continua trasformazione. Grandi emozioni e suggestioni visive sprigiona la messinscena di Hamletmachine di Heiner Miller, ancora a Spoleto nel 2016. In merito, Giacobbe evidenzia la performance di 35 giovani attori dell’Accademia Silvio d’Amico, simili ad «aure metafisiche senza tempo».
Si tratta di spettacoli di grande eleganza stilistica e formale, declinata da Wilson in una sintassi drammaturgica sempre mutevole, di continua ricerca, tanto che lo stesso regista afferma: «spesso la gente mi chiede di cosa tratta il mio teatro; generalmente rispondo che non lo so. […] per me l’interpretazione non spetta al regista, all’attore o all’interprete: l’interpretazione spetta al pubblico».
Collegamenti
Un padre ci vuole
Ci sono scritti che risuonano come un dialogo mai avviato, un complesso insieme di relazioni che riguardano le infinite realtà, i tanti rimpianti, le parole mai dette di una dialettica sospesa. Luigi Pirandello e Stefano, il figlio primogenito, ovvero Stefano Pirandello, il figlio paterno. Come da titolazione del saggio di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, in cui i due studiosi siciliani ricompongono la drammaticità del rapporto familiare, caratterizzato da un’imprescindibile intensità e da un’autentica tensione etica.
Lo scritto apre la pubblicazione del testo di Stefano Pirandello Un padre ci vuole (Cue Press) interamente giocato sull’inversione dei rapporti fra un padre, Ferruccio, e un figlio, Oreste, un legame conflittuale e indissolubile tale «da rendere volutamente fallimentare qualunque tentativo di fuga», come avvertono i curatori. Volume prezioso perché risponde alle aspettative di quanti oltralpe manifestano un non effimero interesse per il dialogo umano ed intellettuale al fondo di ogni successiva indicazione critica. Nel suo non volersi sottrarre alla spietata complessità del rapporto padre-figlio sostanziato d’immedicabili ferite dell’anima, Stefano mette a nudo tutta la sua poderosa fragilità; che, se per un verso lo induce ad un contrasto drammatico, per l’altro ne sottolinea, all’origine, la volontà di non volersi fare da parte e retrocedere dalle tante private aspettative. La commedia appare nella doppia versione in italiano ed in inglese All You Need is a Father (Cue Press), con traduzione di Enza De Francisci e Susan Bassnett. Si tratta dell’ulteriore tassello della preziosa operazione di circolazione plurilingue avviata da Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, da anni impegnati nel recupero storico e filologico di Stefano Pirandello.
Già tradotti in più lingue, i testi, per mantenere inalterato il sapore corretto della vis espressiva, necessitano di una traduzione che superi lo steccato del bello/brutto, infedele/fedele, operando piuttosto nel mantenimento della ratio testuale. Con l’attuale, le due traduttrici hanno condotto un’operazione di vasta portata, assicurando al testo una pregnanza linguistica e storica di ampia gittata. Il risultato è stato il recupero della reale essenza del prodotto testuale grazie all’accuratezza linguistica e storica inserita in una linea traduttiva che restituisce al testo la sua essenza.
Enza De Francisci, dell’Università di Glasgow, direttrice del programma internazionale di Translations Studies in collaborazione con l’Università di Nankai in Cina, è titolare della complessa operazione di traduzione insieme a Susan Bassnet, già lettrice alla Sapienza – Università di Roma e all’Università di Lancaster, e docente di Letterature comparate all’Università di Glasgow, nel recupero di nessi storici e linguistici magari desueti. Con un lavoro prezioso che è facile riconoscere quale modello di come oggi si dovrebbe fare una traduzione.
Diversi e compositi gli elementi che costituiscono la globalità di una traduzione e tali da sottolineare l’importanza del traduttore in quanto mediatore linguistico. Ma anche voce dialogante con il testo, che accompagna il lettore nella comprensione dello scritto, con la capacità di rendere nella lingua di arrivo il messaggio dell’autore, compensando con la propria esperienza e abilità le differenze a volte profonde che esistono tra le due lingue, sia a livello sintattico sia terminologico. E tutto questo sottolinea senza dubbio l’importanza culturale del ruolo del traduttore; il suo difficile compito è di trasmettere il testo originale a un nuovo pubblico che ha lingua, cultura e conoscenze differenti, mantenendo il rispetto sia per la lingua di partenza sia per la lingua di arrivo.
La traslazione di un testo da un contesto linguistico-culturale a un altro è operazione delicata che comporta innanzitutto il rispetto per il testo originale e per il messaggio da veicolare. Ecco perché la traduzione testuale deve essere un’attività collaborativa tra lo scritto e chi lo traduce. Fondamentale è che il traduttore stabilisca un registro stilistico non univoco ma per ogni singolo personaggio, ed è quanto hanno fatto le due traduttrici, affrontando financo il problema di come attualizzare una lingua che per forza di cose rimane ancorata al tempo dell’ideazione e della resa progettuale.
Il diffuso interesse per l’opera di Stefano Pirandello si segnala all’estero grazie al numero non indifferente di traduzioni nelle più svariate lingue. Non mera operazione di traslazione linguistica, ma un’autentica mediazione e negoziazione culturale, un interagire costante con il testo di riferimento, di cui è prioritario fornire la dimensione di autenticità, pur nella complessità del rendere nel paese della traduzione la reale cifra dello scritto.
Si legge nell’introduzione: «Stefano molto deve, e non potrebbe essere altrimenti, al magistero paterno rimanendo tuttavia schiacciato dal peso di una dittatura famigliare e letteraria», da cui è giunto il momento di affrancarlo e da cui il fratello Fausto, invece, si era sottratto scegliendo una via artistica differente, quella della pittura.
Sarah Zappulla Muscarà mette a fuoco il personaggio di Stefano scrittore e drammaturgo, del tutto autonomo pur nell’apparente similarità tematica che lo accosta al padre. Una vita dolente e travagliata quella di Stefano, vittima di un dramma destinato a ricomporsi soltanto negli anni. Affrontando la disamina dell’odierna operazione culturale, la studiosa accademica evidenzia innanzitutto la necessità di rispondere alla curiosità che all’estero si registra intorno ai nomi dei due Pirandello. Già tradotti in più lingue, i testi, per mantenere inalterato il senso della scrittura, si avvalgono di un intervento mai arbitrario; al contrario, in assoluta consonanza con il pensiero dello scrittore. Ci dice Sarah Zappulla Muscarà: «Quella di oggi in inglese è una traduzione di pregio per la quale le due traduttrici hanno impiegato accuratezza linguistica e storica, inserendosi in una linea traduttiva che restituisca al testo la sua essenza».
I canali di attualizzazione filologica, la declinazione del rapporto dimidiato padre/figlio, il recupero di nessi storici e linguistici, oltre che leggersi come un lavoro egregio, diventano, afferma Enzo Zappulla, Presidente dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano: «Un modello di come oggi si dovrebbe fare una traduzione».
La commedia Un padre ci vuole, curata da Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, è apparsa nella traduzione in francese di Myriam Tanant (Parigi, L’avant-scène théàtre, 2008); in quella greca di Anteos Chrisostomides (Atene, ed. Kastaniotis, 2012); in quella bulgara di Daniela Ilieva (Sofia, 2014); in quella serba di Dusica Todorovic Lakava («Revue de philologie», Filoloski fakulter, Belgrado, xliii, 2, 2016); in quella araba di Amer El Alfi e Naglas Waly (Cairo, Akhbar Al Yourn, 2016 con testo italiano a fronte, Catania, Edizione Ho.u.se, 2017); in quella spagnola di Vincente González Martín (Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2017); in quella inglese di Barbara McGilvray, introduzione di Donatella Cannova (Wellington, New Zeland, in association with Istituto Italiano di Cultura, Sydney, Australia,2017). Cfr. al riguardo Sergio Sciacca, Stefano Pirandello e i suoi traduttori: «Un padre ci vuole», «Pirandello Studies», 41, 2021, pp. 154-169.
Collegamenti
Il corpo in testa
L’attività di Alessandro Garzella viene presentata tramite un lavoro difficile da definire, se non – forse – per via negativa, come nota Porcheddu nell’introduzione. E se il libro «non è un romanzo, non è un racconto, non è un saggio, non è un manuale, non è una testimonianza, non è un pamphlet, non è un diario intimo ma è tutte queste cose insieme», è proprio in questa complessità che troviamo il modo per rispecchiare l’attività di un artista difficile da etichettare.
Tennessee Williams. Modernismo in t-shirt e i rinnovamenti del teatro
Grazie ai suoi personaggi, eroi e antieroi che emergevano dal contesto dell’America del secondo dopoguerra, Tennessee Williams diede vita a un’estetica drammaturgica innovativa e rivoluzionaria. Attraverso l’analisi dei suoi personaggi, il volume disegna un ritratto a tuttotondo, umano e artistico, dell’autore statunitense di alcuni degli indiscussi capolavori della drammaturgia del Novecento.
L’attore e il volto
Il volume raccoglie una selezione di saggi del critico europeo Leif Zern, mescolando ricordi autobiografici, recensioni a spettacoli teatrali, piccoli ritratti del mondo del cinema, analisi teoriche sull’arte attoriale. Da Ingmar Bergman a Lars Norén, fino ad autentici pilastri della tradizione scenica come Louis Jouvet, lo sguardo di Zern si sofferma sulla recitazione, l’immedesimazione dell’attore, in un percorso dove «le emozioni non sono innate ma conquistate con un processo di appropriazione».
Gassman. Oltre il palcoscenico
Un Gassman a tuttotondo. Vittorio, attore poliedrico capace di cavalcare i mezzi che la sua epoca gli offre, esce vincitore grazie al ritratto che ne fa Arianna Frattali, nel senso che il suo essere attore totale – dalla voce straordinaria e dalla fisicità imponente – gli consente di dominare la comunicazione dei suoi anni. E sì, perché l’attore è colui che comunica per eccellenza, anche più di altri professionisti, poiché la sua arte è prima di tutto relazione con il pubblico, da quello più affezionato a quello occasionale.
Nel caso di Vittorio Gassman vale molto più il primo del secondo, in quanto è stato l’artista forse più conosciuto e amato del suo tempo. La studiosa ci offre un taglio preciso, costruito su alcuni saggi (un mix tra quelli già pubblicati e gli inediti) che colgono i momenti essenziali, di svolta, della carriera lanciata di Gassman attore di teatro nel momento in cui si affermano il cinema e la televisione, senza dimenticare il rapporto con la stampa. A uscirne è il profilo di un artista curioso e generoso, che amplifica il senso dello stare in scena anche oltre il palcoscenico, facendo tesoro di una tradizione antica che lui proietta, senza risparmiarsi, verso il mondo nuovo.
Beckett fra le righe. Appunti di lavoro
Sentite questa: «Il teatro per me è prima di tutto svago dal lavoro sulla narrativa. Abbiamo a che fare con un certo spazio e con persone in quello spazio. Questo è rilassante». La frase la pronunciò Samuel Beckett parlando con Michael Haerdter, suo assistente per la messinscena di Finale di partita allo Schiller Theater di Berlino, nel settembre del 1967. A riportarla è Stanley E. Gontarski nell’introduzione alla pubblicazione del quaderno di regia dedicato appunto al testo e alla sua revisione da parte dell’autore, in versione italiana meritoriamente pubblicato dall’editore Cue Press. Lasciando da parte il piacere del dettaglio che tale revisione produce, insieme alla pura emozione suscitata dal poter leggere gli appunti nella scrittura di Beckett – cose preziose che si devono lasciare alla relazione personale del lettore con il libro – bastano queste parole per capire come anche un autore considerato, a buon diritto, uno scrittore di letteratura, comprenda la necessità di un’altra grammatica quando si tratta di uno spettacolo. Insomma, anche Beckett venne rapito dalle necessità della «scrittura scenica», indispensabile sviluppo della «scrittura drammaturgica», poiché chi scrive per il teatro, o quando si scrive per il teatro, lo si fa per essere rappresentati piuttosto che letti. In precedenza era accaduto a un altro immenso autore, il nostro Pirandello, che a contatto con gli attori, in verità più Ruggeri e Melato (con sullo sfondo Talli) che Musco, comprese che quella che si parla sul palcoscenico è un’altra lingua da quella che si scrive sulla carta. In più, Beckett nella sua dichiarazione sottolinea per ben due volte la parola «spazio». Il segreto sta proprio lì, nell’intuizione di ciò che rende possibile la messinscena e dunque il teatro: lo spazio, dove azione e movimento producono il tempo. Il luogo dove tutto diviene grazie alla determinante presenza dell’attore, insieme al respiro dello spettatore.
Nel laboratorio creativo di Koltès
«Non desidero che una cosa: essere capace di correre dei rischi», scrive Koltès nel marzo del 1968. Prima della rivoluzione. A neanche vent’anni. E proprio l’età acerba è al cuore della conversazione a distanza con la madre, per tutta la vita confidente privilegiata. È in quei giorni che il drammaturgo decide di dedicarsi al teatro. Passaggio fondamentale. Ma solo uno fra i tanti. Volume densissimo infatti quello di Cue Press, che porta in Italia il progetto delle Éditions de Minuit, qui con la preziosa curatela di Stefano Casi. Una raccolta di lettere, biglietti d’auguri, telegrammi, ringraziamenti. C’è di tutto. Ad alimentare una certa filologia mitizzante. L’aria bohémien. Ma con l’andare del tempo, mentre si spulcia nei cassetti, la prosa si allunga. E così i pensieri. Emerge l’uomo. Insieme a riflessioni che diverranno centrali nella sua produzione. Si pensi solo all’impossibilità della parola di fronte alle profondità del sentire. Anche se mai Koltès abbandonerà quell’irrequietezza così identitaria, sintetizzata nel 1981 in una cartolina da New York: «Qui abbondano le persone della mia razza, caratterizzate da: inquietudine (fondamentale), disperazione assoluta (senza tristezza) e gusto del piacere».