Logbook
Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

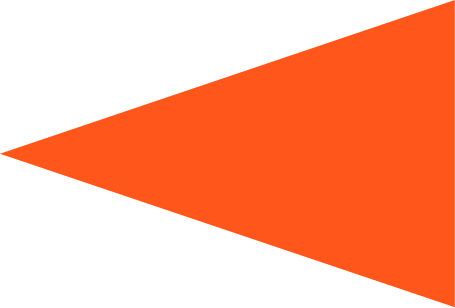
Zombitudine: dal teatro al libro
A fine gennaio Zombitudine subisce una trasformazione, sarà disponibile per l’invasione delle librerie nel formato cartaceo e digitale.
La casa editrice Cue Press, specializzata nella pubblicazione di testi e saggi teatrali, ha infatti pubblicato il libro Zombitudine di Elvira Frosini e Daniele Timpano.
Un uomo e una donna sono rifugiati in un teatro insieme al pubblico. Qualcosa sta arrivando. La minaccia è là fuori ed il teatro è l’ultimo spazio di salvezza in cui rifugiarsi nell’attesa della loro venuta.
Sì, ma loro chi? Gli zombi? La morte? I rivoluzionari? Un evento che cambierà la storia? Non lo sappiamo. Non lo sa il pubblico e non lo sanno l’uomo e la donna, sul palco in logorante e beckettiana attesa.
Forse arrivano gli zombi, ma non sono esseri mostruosi. Siamo noi. Automi che si trascinano già morti lungo traiettorie claustrofobiche e obbligate, sui binari in decomposizione di questa società frenetica e insensata, dove pericolo e salvezza sono la stessa cosa e i vivi ed i defunti hanno lo stesso inutile afflato rivoluzionario.
Oltre alla drammaturgia dello spettacolo Zombitudine, il libro contiene una prefazione di Gianfranco Manfredi, cantautore e sceneggiatore di fumetti, tra gli altri, per Sergio Bonelli Editore; un saggio dello studioso Federico Boni, docente di Sociologia dei processi Culturali e Comunicativi alla Statale di Milano, e una postfazione di Daniela Ferrante, organizzatrice della Compagnia Frosini Timpano per la produzione del progetto Zombitudine.
«Che li si prenda singolarmente oppure in coppia, Elvira Frosini e Daniele Timpano sono fra le presenze più imprevedibili e provocatorie del teatro italiano di oggi: ogni loro intervento graffia, disturba, spiazza la sensibilità dello spettatore. Il loro nuovo spettacolo si intitola non a caso Zombitudine, e vuole assumere sarcasticamente la condizione dei morti-viventi come emblema dell’Italia di oggi, metafora di una fine collettiva, ma anche di una paradossale speranza di rinascita» (Renato Palazzi, «Il Sole 24 Ore»).
Collegamenti
Caldo
Nel percorso creativo dell’infaticabile Jon Fosse – puntellato di opere diventate fondamentali per la drammaturgia contemporanea, tradotte e rappresentate anche in Italia come Qualcuno arriverà, Sogno d’autunno, La ragazza sul divano – il testo Caldo (Varmt) aggiunge un altro prezioso tassello al processo di scarnificazione del linguaggio e della struttura dei personaggio proprio dell’autore.
La forza di questa opera presentata in prima mondiale al Deutsches Theater di Berlino nel 2005 per la regia di Jan Bosse e proposta in versione italiana al Teatro Tor Bella Monaca di Roma nel 2017 (regia di Alessandro Machia; con Alessandra Fallucchi, Giorgio Crisafi e Luca Mascolo), sta nella rinnovata rivisitazione delle lezioni di Pinter e Beckett, da sempre fondamentali fonti ispiratrici del drammaturgo norvegese.
Siamo nel minimalismo estremo che si concretizza in dialoghi brevi e strutturati su una struttura sintattica di poche parole lunghe come un respiro o un sospiro, tanto da animare «una parata di fotogrammi di esistenza che restano sospesi, quasi a sancire che esistere è più che stare […] che un divenire», scrive in merito Franco Perrelli nella preziosa introduzione (Jan Fosse e il dramma dell’attesa) al libro da lui stesso tradotto.
Eppure in questi continui silenzi calati in un’atmosfera rarefatta, dove l’andamento cronologico è disturbato dai capricci della memoria, i personaggi si manifestano nella loro dimensione di essere-non essere, rivelarsi e scomparire nel nulla. Alla paralisi delle loro non-azioni manca lo sfogo tragico. L’incontro-scontro tra passione e pudore come inizia, così finisce: dal nulla al nulla.
I protagonisti di Caldo sono Il primo uomo, Il secondo Uomo, Una donna. Forse sono due perché i due uomini, l’uno prossimo alla terza età e l’altro nella fase della giovinezza, si alternano e si intrecciano nei dialoghi con la figura femminile che è (o è stata) moglie di entrambi e dai quali ha avuto figli. Il luogo dell’incontro è un pontile, vicino al quale si trova una misteriosa casa dove si sono consumati gli amori e che nei dialoghi è spesso evocata per poi scomparire come una bolla di sapone, come il ricordo lontano di una mente lucida-confusa. Alla stessa maniera si dissolvono nel gioco vorticoso delle immagini altri segni connotativi: il costume da bagno della donna indossato in una calda e sensuale estate, le belle forme del suo corpo, i suoi capelli bagnati.
Nelle battute conclusive si sostanzia l’essenza poetica di Caldo:
«IL PRIMO UOMO Ma noi stiamo qui IL SECONDO UOMO Noi stiamo qui DONNA Qui dobbiamo stare noi IL SECONDO UOMO Forse IL PRIMO UOMO Noi dovremmo IL SECONDO UOMO Certo noi dobbiamo stare qui»Sono parole che evocano forme scheletriche di esistenza enigmatiche e significative. Forse la trasfigurazione delle nostre.
Collegamenti
Roland Schimmelpfennig. In un chiaro, gelido mattino
Il nome è molto difficile da pronunciare. E anche da ricordare. Ma bisogna farlo, questo sforzo, giacché Ronald Schimmelpfennig è sicuramente tra i massimi scrittori contemporanei tedeschi e non solo. Generazione 1967, originario di Göttingen e formatosi a Monaco, Schimmelpfennig è tra i drammaturghi viventi più rappresentati al mondo. La sua più importante messinscena italiana – nonché, che io sappia, l’unica – è del gennaio 2014, al Piccolo Teatro di Milano: Visita al padre, uno spettacolo magnifico con Paola Bigatto, Anna Bonaiuto, Caterina Carpio, Marco Foschi, Mariangela Granelli, Massimo Popolizio, Sara Putignano e Alice Torriani, nella regia profonda e intelligente di Carmelo Rifici.
Visita al padre è rimasto per cinque anni anche pressoché l’unico lavoro reperibile in italiano dell’autore tedesco (pubblicato da Cue Press): un testo nevrotico, quasi spastico, tutto incentrato sul tema della perdita. La trama è molto semplice, con echi archetipici: Heinrich, il padre, si è autoesiliato in una grande villa, circondato da quella che oggi si definirebbe una famiglia allargata: la moglie, la figlia, la figlia della moglie, la nipote, una congerie di donne tra cui il padre regna, tra estenuanti sessioni di cucina e una traduzione del Paradiso perduto di Milton a cui lavora da più di dieci anni. Una mattina bussa alla porta un ospite inaspettato: Peter, figlio di Heinrich nato da una dimenticata relazione giovanile, e da lui mai conosciuto. L’arrivo di Peter scatena una incontrollabile reazione di eventi a catena, che porteranno all’espulsione del figlio dal nucleo familiare, sancendo in maniera definitiva la sopraffazione dei padri nei confronti dei figli: ribadendo simbolicamente il diritto dei primi a detenere per sempre il possesso della casa e l’uso patriarcale delle donne presenti; con l’eccezione della giovane Isabel, che invece fugge via con Peter. I seguenti due capitoli della trilogia seguiranno proprio le vicende tragicomiche di questi due figli.
Visita al padre è un testo che come pochi altri affronta il tema della perdita: una perdita irrimediabile, consumatasi nel passaggio tra una generazione e l’altra: l’incapacità di una generazione a comunicare alla successiva qualcosa di fondamentale eppure mai esplicitato, forse proprio perché incomunicabile. Cosa? Un linguaggio, un modo d’intendere la sensualità, un significato, una nozione di ordine, un’identità, una disciplina, una forma. In Visita al padre questo vuoto di passaggio si verifica infatti tutto al livello della comunicazione. Lo si vede non solo nei contenuti ma anche nelle forme, nei modi con cui Schimmelpfennig utilizza le strutture teatrali: decostruendo, procedendo per frammenti e materiali, come nella migliore tradizione post-drammatica contemporanea soprattutto tedesca, ma conservando di quelle strutture scomposte proprio il grosso spessore tradizionale, la grana dura dell’archetipo: i richiami a Ibsen, a Cechov, a Brecht, insomma ai punti cardine del teatro della generazione dei ‘padri’. Chi siano poi questi padri, Schimmelpfennig sembra segnalarlo con inesorabile chiarezza: sono gli ultimi che hanno avuto contatto con chi ha fatto esperienza della guerra. Non è un dettaglio da poco. La villa di Heinrich è situata in un luogo la cui peculiarità è quella di essere stata teatro di moltissime guerre. Heinrich, il padre, il patriarca, non è solo il maschio alfa dominatore di una tribù di donne, ma è anche l’unico in famiglia a saper usare un’arma. Il padre è, qui, soprattutto colui che è ancora in grado di usare la forza. Il figlio, che invece non ha forza ma solo una stracca, distratta sensualità, non può far altro che capitolare, scappando via insieme a Isabel, l’altra figlia di Heinrich.
[…]
Collegamenti
«Il teatro è un coro del noi», il manifesto di Marco Martinelli
«Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, perché il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, dell’ignoto, della vita, della morte».
Lo immaginava così il teatro Leo De Berardinis in uno dei suoi tanti scritti sul cosa e come deve essere il teatro. Cosa e come: i due interrogativi che chi abita quel luogo mette in discussione continuamente, senza mai porre l’ultima parola. Il teatro è visione, costruzione di rapporti, di comunità. Il teatro è pena e antidoto, rivelazione dell’essere e costruzione del noi.
Il teatro è un fare. Un fare ben conosciuto a Marco Martinelli, regista e drammaturgo, poeta di compagnia del suo Teatro delle Albe di Ravenna, autore di Farsi Luogo. Varco al Teatro in 101 movimenti, presentato in una particolarissima lettura scenica sabato scorso al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia.
Animali a sangue caldo
Un Farsi Luogo che è quasi una partitura dell’anima, un manifesto per immaginare il teatro come luogo del visibile, del necessario, dell’utile. Un manifesto che, nella molteplicità di esempi e suggerimenti che vengono dall’esperienza diretta di trent’anni di lavoro in una delle compagnie più apprezzate del panorama italiano, mette le comunità del teatro sin da subito di fronte ad un dilemma: cosa fare? Cosa fare di un teatro che deve essere vivente, pulsante come un animale a sangue caldo? Cosa fare di un teatro che si illude del ‘possibile’, dei muscoli, dell’io, delle rivoluzioni umane e sociali ancora da innescare?
Martinelli risponde con un linguaggio narrativo e con parole costruite nei perimetri del suo modo di fare teatro, nella sua ‘spirale’ dove le pratiche e le idee sono già solide e pronte per contaminare e germogliare. Allora indica la strada: dalla mancanza di rivoluzioni («ogni epoca è buona per accendere una miccia») alla schiavitù del possibile, inaccettabile perché farsi luogo è, soprattutto, andare oltre il possibile. Una chiamata alle idee per costruire un noi solido, un riflesso di quell’io che si specchia negli occhi di una seconda persona che è l’essenziale, un coro da costruire che sia presente a quell’esercizio di cittadinanza che il teatro dovrebbe istituire.
Dal personale si passa al politico senza intravedere con chiarezza i limiti e i confini. Limiti sottilissimi, perché il teatro è ovunque e la politica e il teatro sono due modi di ‘mettere in vita’ la società. La vita invade la scena, ricorda più spesso il regista nei suoi punti sparsi nel libro.
Essere disarmati
La rivoluzione dentro di noi, l’esercizio di comunità, la spirale che si allarga per includere gli opposti della polis costituisce il legame del noi con la ‘materia sacra’ del teatro. Così diventa luogo dell’esplorazione dell’essere cittadino, spazio fisico della democrazia comune. In teatro bisogna essere disarmati: i muscoli si annullano, le armi non servono, le lingue si uniscono al coro comune, l’io è in penombra. Il meticciato non è un compromesso ma è una ‘felice condanna’, il migrare aiuta, la bellezza non è estetica ma è etica della bontà.
Il sottotitolo del libro, Varco al teatro in 101 movimenti, è molto eloquente. Marco Martinelli con questo pamphlet pubblicato dalla casa editrice di Mattia Visani (la prima casa editrice italiana dedicata alle arti dello spettacolo) cerca di scavare un varco, allargare una fessura aperta in un mondo ripiegato su se stesso. Scrive ripetutamente: «Più che la messa in scena mi interessa la messa in vita, un corto circuito, un legame infuocato tra gli artisti e i cittadini».
Teatro e anima
Alla base c’è questo messaggio: il teatro non rinnega la sua anima quando si preoccupa dei problemi che lo circondano, quando ingloba quel reale nelle sue mura mescolando vita e finzione, assieme mondi drammaturgici e vitali. Il teatro è luogo del fare quando si confronta con le contraddizioni della vita sociale. Si fa luogo quando affoga in questo campo indistinto. Il fondatore del Teatro delle Albe, conosciuto per la non-scuola e per quei due asini, simboli della compagnia, condannati ad ascoltare tutti i lamenti del mondo, ci ricorda che è un metodo da recuperare perché è stato sempre così, da Aristofane a Brecht: teatro e polis.
La scena e la vita, la finzione e la realtà. Una convivenza comune inscindibile: perché teatro è insieme sociale senza etichette. È un noi, è un coro da amplificare per ritrovare quell’io sono noi e recuperare una responsabilità politica comune per essere singolo nell’insieme.
Così, la narrazione di Martinelli diventa un manifesto sull’utilità del teatro come collante sociale, quasi un’ancora per salvarsi assieme dai mali comuni.
«Il Novecento che abbiamo alle spalle è un secolo monologante, riflesso di un solipsismo sempre più disperato, della perdita di identità nella società di massa, della perdita di che cosa significhi essere comunità. A me sembra che pensare il coro, oggi, agirlo al centro della scena, possa far ritornare i drammaturghi e registi alla questione politica per eccellenza, al legame di sangue del teatro con la società».
Collegamenti
L’irrefrenabile Savinio. Non solo musica e pittura. Visionario di una scena mitico-surrealista, scardinò il teatro borghese
Ad Alessandro Tinterri, che insegna Storia del teatro all’Università di Perugia, dobbiamo un libro fondamentale su Piandello capocomico, edito da Sellerio nel 1987, dove sono elencati, con relative distribuzioni, i cinquanta spettacoli realizzati al Teatro D’Arte, nelle Stagioni 1925-28, dove figurano autori come Massimo Bontempelli con Nostra Dea (22 aprile 1925), Alberto Savinio con La morte di Niobe (14 maggio 1925), Rosso di San Secondo con Marionette, che passione (29 giugno 1926).
Dei tre, Tinterri ha scelto di dedicare gran parte dei suoi studi a Savinio, curando, per Adelphi, i testi teatrali, i romanzi, le critiche raccolte in Palchetti romani, mentre con le edizioni del Mulino pubblicò una monografia (1993) che, in edizione riveduta e corretta, viene riproposta da Mattia Visani per Cue Press.
Anche questo fu, allora, un libro fondamentale, proprio perché c’era bisogno che qualcuno desse ordine a un autore un po’ disordinato come Savinio, la cui irrefrenabile fantasia spaziava tra generi diversi, ovvero tra musica, pittura, teatro, con incursioni nella scenografia e nella regia.
Per Tinterri, Savinio doveva ritenersi uomo di spettacolo, essendo, il palcoscenico, il luogo ideale dove potesse trovare approdo il suo multilinguismo. Tinterri si chiede, e me lo chiedo anch’io, perché la scena italiana, che pullula di autori improvvisati, non smetta di essere in ritardo su autori come Savinio, Rosso, Bontempelli, che costituiscono il meglio di quel periodo rivoluzionario che li vide muoversi con e attorno a Pirandello, con lo scopo di inserire il teatro italiano in una dimensione europea, contribuendo, non solo all’innovazione linguistica, ma anche scenica.
Per questi autori contava la parola, alla quale, specie per Savinio, spettava il compito di creare delle ‘visioni’ che l’attore doveva rivestire con voce e corpo. All’inizio del Novecento, si affermarono i movimenti avanguardistici, ai quali dette un contributo determinante il futurismo, un po’ meno D’Annunzio con i due Sogni, che tendevano, involontariamente, al simbolismo. Savinio, Rosso e Bontempelli, sotto la guida di Pirandello, cercarono di scardinare il teatro borghese, ma fu Savinio l’autore più avanguardista, avendo inserito la sua scrittura scenica in una dimensione mitico surrealista, tanto da mettere in crisi i suoi esecutori, come accadde a Strehler quando curò la regia di Alcesti di Samuele con attori non adatti a quel tipo di teatro, come Pilotto e la Brignone.
Tinterri ci racconta come e quando Savinio si era convertito al teatro, ma anche le vicissitudini di Capitano Ulisse, pronto per andare in scena al Teatro D’Arte, ma che dovette accontentarsi di una messinscena raffazzonata al Teatro degli Indipendenti di Bragaglia (1938) con la regia improvvisata di Nando Tamberlani. Bisognerà attendere il 1990, quando Pietro Carriglio, allora direttore del Biondo di Palermo, commissionò a Mario Missiroli la regia di Capitano Ulisse, che fu presentato come un vero e proprio classico, benché Missiroli si fosse lasciato prendere la mano, ricorrendo a generi diversi che, sul palcoscenico, fecero stridere alquanto.
Ne fummo testimoni io e lo stesso Tinterri. Sono, però, convinto che autori come Rosso, Bontempelli e Savinio, abbiano bisogno di grandi istituzioni teatrali o grandi compagnie per essere rappresentati. Lo capì Egisto Marcucci che con Emma B vedova Giocasta realizzò uno spettacolo esemplare, con Valeria Moriconi protagonista, con la quale realizzerà un altro testo, tratto da un racconto La nostra anima, che debuttò al Festival di Spoleto. Ma è giusto anche ricordare La partenza degli Argonauti, con la regia di Perlini e Il coturno e la ciabatta di Ida Omboni e Paolo Poli. Poi, il silenzio. Il volume di Tinterri potrebbe essere d’auspicio a nuove messinscene.
Collegamenti
Un vigile contro la ʼndrangheta. In Calabria? No, in un tranquillo paesino romagnolo. La piovra ormai è dappertutto
Recensire un testo che è nato per la scena è diverso che recensire lo spettacolo da cui è tratto. Si utilizzano metodologie d’approccio diverse perché, se il lettore è portato a fantasticare, lo spettatore di professione ricorre a canoni di giudizio diversi.
Il testo trattato è Va pensiero di Marco Martinelli, pubblicato da Cue Press nella collana che Mattia Visani ha dedicato alla drammaturgia del terzo millennio. Perché ho scelto Va pensiero? Perché, da tempo, mi occupo di teatro e mafia, avendo esaminato, in un volume omonimo, una serie di commedie e di drammi che dal 1867 al 2011 hanno trattato l’argomento.
Il testo di Martinelli lo affronta in maniera alquanto personale, con un uso particolare dell’ironia e della leggerezza, tipica della drammaturgia brechtiana, della quale ha sfruttato certe intelaiature, tipo: brevi scene, anticipate da scritte didascaliche visualizzate su uno schermo, con l’idea geniale di sostituire i song con cori e aree famose, tratte da opere verdiane, senza la retorica del palcoscenico ad uso della legalità. In questo testo non c’è nulla di retorico, c’è solo teatro dove, in ventisette brevi capitoli, viene raccontata la storia di un semplice vigile urbano, con velleità di cronista, che denuncia, non certo per coraggio, ma perché crede nella professione che svolge, quell’atmosfera di corruzione che il suo paese sta vivendo, dopo l’arrivo di un imprenditore ʼndranghetista.
Non siamo né in Sicilia, né in Calabria, bensì in un paesino di Romagna, apparentemente tranquillo, diventato, per la ʼndrangheta, terra di conquista, come dire che la piovra si è estesa in tutta Italia, creando situazioni da vomito. Non per nulla, quando il sindaco, soprannominato la Zarina, che in teatro è interpretato da una straordinaria Ermanna Montanari, quando entra in scena, vomita.
L’argomento trattato, alterna la verità con la verosimiglianza, visto che il processo Aemelia si è concluso, a Reggio Emilia, un anno dopo la stesura di Va pensiero, il 18 Ottobre 2018, con la condanna di 118 persone collusi con la ʼndrangheta, tra i quali, politici e imprenditori.
Non ci sono situazioni drammatiche, nel testo di Martinelli, bensì incursioni epiche su una materia riprovevole per la quale si è chiamati, non a partecipare, bensì a riflettere. Del resto, la tecnica del racconto è di tipo corale, alla quale Martinelli ci ha abituato da tempo. Attenzione, però, i personaggi non sono da operetta o, se lo sono, bisogna pensare a Mahagonny. Recensendo lo spettacolo, Renato Palazzi ha scritto sul «Sole»: «Si tratta di uno dei più importanti tentativi di questi anni di cogliere il tempo che stiamo attraversando, forse del primo vero dramma scritto oggi sull’Italia di oggi».
I protagonisti sono personaggi tipici di un piccolo paese di provincia, microcosmo di un paese molto più grande, i cui tentacoli arrivano in Europa. Oltre il sindaco e il vigile urbano citati, si muovono segretarie, imprenditori onesti, addetti stampa alquanto fantasiosi, consulenti finanziari, gelatai che chiudono per non pagare il pizzo. Ci sono anche due cacciatori di nutrie che al lettore fanno pensare ai topi della Peste di Camus, o a I rinoceronti di Ionesco.
Il volume contiene un’antologia critica e una vasta bibliografia sul tema della mafia.
Collegamenti
Una stagione teatrale lontana dal presente
Il teatro non è mai immune da ciò che accade nella vita sociale, anzi ne è il testimone visibile e invisibile, suo compito è quello di sviluppare il pensiero critico col solo mezzo che ha a disposizione, quello del linguaggio scenico che può essere di tipo rappresentativo o performativo.
Milano ha scelto, con i suoi teatri più importanti, il primo tipo, con abbondanza di adattamenti, riscritture, rielaborazioni di classici antichi e contemporanei e con risultati che accontentano il botteghino. Mantenere uno stile, un’idea per cui si è nati, è diventato alquanto difficile. Spettacoli come La tragedia del vendicatore al Piccolo o come Afghanistan all’Elfo o Un cuore di vetro in inverno di Timi al Parenti, lasciano un segno, ma non indicano un nuovo tracciato nell’ambito di un futuro diverso, al quale si sforzano di dare un contributo nuovi gruppi o Collettivi che, pur visti a Milano, fanno ricerca in altre sedi, con risultati molto referenziali, con cast diseguali, con molta libertà nella recitazione.
Si tratta di Collettivi che cercano l’effetto scandalo o la cronaca che fa notizia. C’è da dire che neanche le due sedi dove si fa ricerca, ZONA K e Triennale Teatro dell’Arte, si siano contraddistinti per continuità, benché spettacoli come Nachlass, My Documents, Project Mercury, Perhaps all the Dragons abbiano creato uno spiraglio di ricerca alternativa, tutta di matrice straniera, dove ad imporsi è proprio il teatro performativo che cerca di dare voce al presente, facendo uso della tecnologia e di piattaforme digitali.
Molti di quelli che si ritengono performer sono attori mancati. Per questo motivo, consiglio loro di leggere il volume, appena uscito, di Richard Schechner: Introduzione ai Performance Studies, edito da Cue Press. Comincio col dire che la Performance appartiene a una tradizione interculturale antica, con delle forme specifiche, con le quali si manifesta, che coinvolgono discipline diverse. Si potrebbe affermare che si tratti di uno spettacolo-evento, da considerare qualcosa di unico e irripetibile, tanto che luogo e tempo derivano dall’evento stesso, essendo caratterizzati dalla simultaneità, oltre che dalla casualità.
In molti casi, si tratta del teatro senza spettacolo, quello che fu, per esempio, teorizzato da Carmelo Bene, in qualità di direttore della Biennale di Venezia (1989-91), quando portò in scena il Nulla, a dimostrazione di essere stato un vero performer, oggi ricordato come tale, dato che i suoi testi, senza di lui, non possono avere vita scenica. Schechner offre un ‘manuale’ che contiene molti interventi di studiosi che si sono occupati dell’argomento e che propongono un panorama internazionale sugli studi che hanno caratterizzato la storia della Performance e del suo rapporto con le Arti dello spettacolo, dei Rituali, del Gioco, della Recitazione, dei Processi formativi, sia globali che interculturali.
Egli cita più volte Goffman, autore di un classico della sociologia: La vita quotidiana come rappresentazione (1959), in cui lo studioso utilizza la metafora teatrale, direi con grande competenza, da applicare alla vita sociale, ma cita anche i suoi incontri con Victor Turner, al quale dobbiamo due altrettanto classici, pubblicati nel 1986: Dal rito al teatro e Antropologia della Performance, della quale vengono affrontati i diversi generi. Schechner si mette in continua relazione con Turner, teorizzando la sua idea di Performance, da intendere come una sequenza di atti simbolici che hanno a che fare con la vita dei popoli e dei loro ‘drammi sociali’, tanto che il suo carattere di messinscena si interseca, in molti casi, con gli accadimenti sociali, evidenziando le crisi che producono tutte le situazioni liminali.
Il teatro è ancora necessario? Lo sarà finché darà voce al presente e ai dubbi della nostra esistenza.
Collegamenti
Necessità e utopie degli Stracci della memoria
«Ricucire i resti delle nostre differenti memorie (individuali, storiche, antropologiche) e ripararne i traumi nell’unità di uno spettacolo-rito». Una proposta deflagrante, utopica, forse la diremmo provocatoriamente fuori moda, oggi, e perciò più che mai necessaria.
È questo il senso di Stracci della Memoria, progetto internazionale pluridecennale di ricerca e formazione nelle arti performative a cura di Instabili Vaganti e ora titolo del volume dedicato al loro lavoro. Lo riporta bene nella prefazione di Silvia Mei, Sulle rive della memoria, facendo emergere le tre principali direttive, che si riversano l’una sull’altra a cascata, intrecciandosi nei diversi capitoli della loro esperienza: il ‘viaggio’ come azione fondamentale, destrutturante e stimolante, attraverso la quale la compagnia bolognese recupera questioni e stimoli; l’importanza, dunque, dell’idea di ‘spazio’ come luogo soggettivo e aperto; infine l’abbattimento della barriera linguistica, ‘l’universalizzazione del linguaggio’ come corollario necessario alle prime due.
Un testo che nasce da dentro, dalla volontà di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola – performer, registi e pedagoghi – di raccontare le proprie modalità formative in giro per il mondo, dal Kosovo a Matera, dal Messico alla Cina. Emergono due forze speculari e necessarie l’una per l’altra: una prima esplosiva, che pone sul piatto differenti forme artistiche incontrate e desiderate, i diversi linguaggi, diversi luoghi e diversi approcci; e dall’altra parte una forza aggregativa, che prova dunque a ricucire, a mettere insieme, a dare un senso all’entropia contemporanea.
Un bisogno di unità, che prende la «forma di brandelli d’arte dispersi in ogni luogo», come afferma Dorno nella sua dichiarazione introduttiva, quasi un manifesto del proprio lavoro, iniziato nel 2006 e che ha come parola totem la memoria, nella sua azione di recupero e al contempo di necessaria selezione. Su tutto aleggia almeno un nome, fondativo della ricerca teatrale secondo-Novecentesca: quello di Jerzy Grotowski, punto di riferimento, fonte storica e critica, a cui si accompagnano altri numi tutelari, da grandi letterati del passato ad alcuni studiosi contemporanei.
In questo volume, edito da Cue Press nel 2018, i capitoli centrali presentano singolarmente le tappe del percorso di Instabili Vaganti e in maniera chiara restituiscono i concept di lavoro, i workshop, le performance e le loro temporanee conclusioni, raccordate da conversazioni con gli artisti, testimonianze e restituzioni critiche provenienti da tutto il mondo. Conseguenza naturale e, quasi radice ante litteram di questi Stracci, è anche il recupero del diario di bordo pubblicato dal 2014 al 2016 da «fattiditeatro.it» che, come racconta Simone Pacini, derivava dall’esigenza della compagnia di restituire l’intensità delle esperienze artistiche e umane vissute.
Infine, una galleria fotografica restituisce quella forza materica di «corpi in presenza», ombre granitiche stagliate su un video, sulla granulosa terra, bendate, bagnate, affaticate. «Memorie sotterranee» pronte a esplodere, per poi ritrovarsi ricucite in una utopica e necessaria grammatica dell’uomo.
Collegamenti
Stracci della memoria
C’è un respiro profondo nelle pagine di Stracci della memoria, il volume edito da Cue Press nel quale Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, fondatori di Instabili Vaganti, attraversano la genesi e lo sviluppo, composito, frammentario, fervido, dell’omonimo progetto internazionale di ricerca e di formazione nelle arti performative da loro ideato, e che dal 2006 li conduce in giro per il mondo.
Un percorso dettagliato nelle sue varie articolazioni che esplora le sinergie e gli innesti fra nuove modalità di espressione artistica e di comunicazione teatrale, tramite l’interazione con discipline quali l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media, la danza, la musica. E che ora affida alla forma aperta di un libro, che è al contempo antologia di visioni, mappa esplorativa, galleria fotografica, il racconto vibrante di un’esperienza che parla di teatro e al teatro.
Anna Dora Dorno, regista, attrice, pedagoga della compagnia, scrive nell’introduzione: «Nato da un’assenza, o meglio, come reazione a una mancanza, di spazi, risorse e condizioni che erano per noi indispensabili, Rags of Memory [Stracci della memoria] ci ha consentito di trasfigurare in modo creativo la nostra precarietà, sviluppando uno specifico metodo di lavoro capace di utilizzare differenti forme artistiche, in base alle risorse, ai mezzi e ai luoghi che avevamo a disposizione in quel preciso momento».
Sperimentazione, dunque, e un continuo contagio di esperienze, metodi e tecniche apprese dagli attori, artisti visivi, musicisti e performer incontrati nei diversi paesi che hanno ospitato il progetto, partendo da Bologna per arrivare alla Polonia, Romania, Kosovo, Svezia, Tunisia, Armenia, India, Cina, Corea, Messico, Cile.
Provare a ricomporre nella pagina la complessità di questo processo artistico e delle fasi che l’hanno segnato, dall’elaborazione fino alla sua maturità performativa, significa affidarsi alla scrittura e alla sua capacità di rinnovarsi nel tempo, per farsi deposito vivo della memoria. Memoria che, nella sua triplice accezione di individuale, storico-sociale e antropologica, costituisce il fulcro d’indagine e dell’evoluzione del progetto di Instabili Vaganti, che ne ricuce insieme i pezzi nello spazio rituale di uno spettacolo dalla geografia diffusa.
«Il fine è quello di scoprire l’essenza dell’atto performativo, di giungere al nucleo primitivo dell’azione, al movimento puro, alla scomposizione del testo in parole essenziali, del brano musicale in effetti sonori, della melodia in forme ritmiche di base, nel tentativo di definire una nuova ritualità». E sfogliando il testo siamo in grado di rintracciare nella sua anatomia ibrida quel movimento creativo e quella necessità che hanno dato origine a l’intero percorso.
A partire dal capitolo iniziale dedicato alla memoria del corpo e agli impulsi che generano l’azione performativa, di fatto, la prima fase di ricerca nella genesi di Stracci della memoria. Passando, nel secondo capitolo, alla memoria collettiva e alla sua capacità di farsi carne nel corpo dell’artista, attraversandolo di ricordi personali e dell’umanità tutta. Nel terzo capitolo, la ricerca di Instabili Vaganti giunge a toccare il suo ultimo punto d’indagine, scoprendo nell’internazionalità degli artisti chiamati a raccolta, la possibilità unica di ricostruire un’identità collettiva fluida, nutrita dalla tradizione ma con lo sguardo puntato al presente e alle sue contaminazioni. Si arriva, poi, alle attività pedagogico-formative realizzate in giro per il mondo, vero cuore pulsante di Stracci della memoria, per il confronto culturale e il dialogo multidisciplinare che hanno attivato.
Due gli iter formativi testati grazie all’esperienza verificata sul campo: il primo, destinato ad avvicinare performer professionisti al training e alla metodologia creati, consiste in sessioni internazionali di ricerca; il secondo, volto ad ampliare il raggio d’azione delle persone coinvolte e da coinvolgere nel progetto, è rappresentato dai workshop.
Il volume dedica un’intera sezione ai diari di viaggi pubblicati da Instabili Vaganti sulla webzine di Simone Pacini «fattiditeatro.it», con il racconto delle trasferte mondiali della compagnia, tra cui le tappe in Tunisia, Corea del Sud, India, Cina di Rags of Memory. Una collaborazione nata nel 2014 e che ad oggi conta più di sessanta post. Una galleria di immagini e una cronologia a compendio delle diverse tappe del progetto, chiudono il volume, lasciando a un ultimo, aperto affondo finale, lo spazio per interrogarsi su quello che sarà dopo.
Chiosa Silvia Mei nella sua prefazione: «Stracci della memoria non conclude la sua parabola col libro che lo racconta. È piuttosto il volume a rilanciarne la forza e a permettere nuova circolazione al progetto». Percorrerlo con le dita significa addentrarsi in un non-luogo del ricordo, che continua a ridisegnare la sua strada.
Collegamenti








