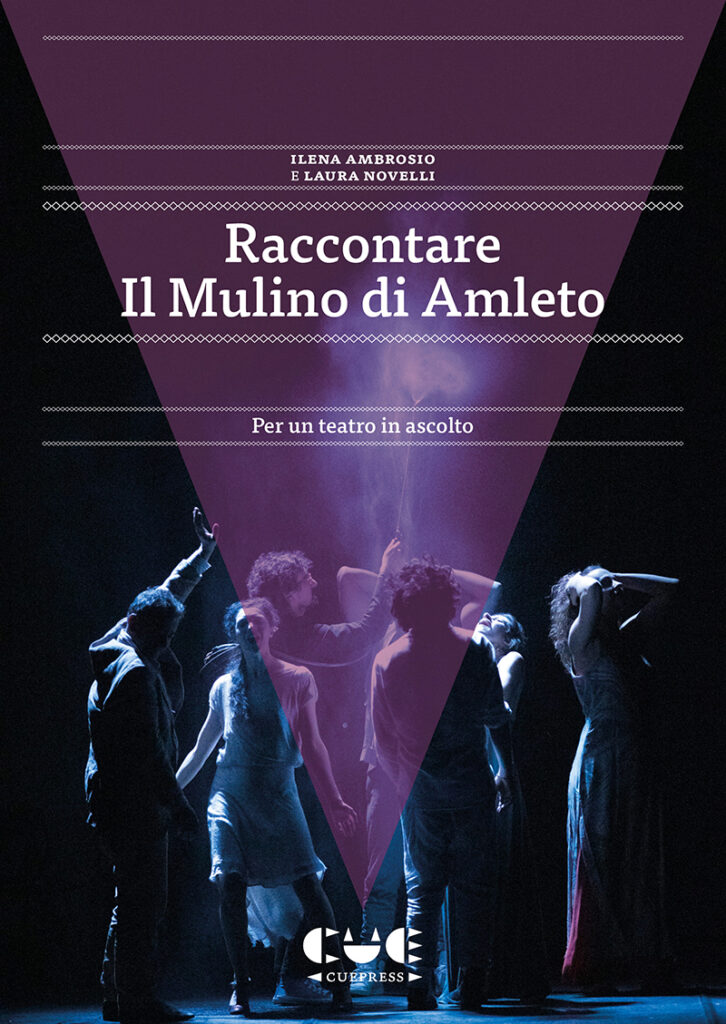L’umanità, il testo, il processo. Il Mulino di Amleto letto da Ambrosio e Novelli
Carlo Lei, «Krapp's Last Post»
Raccontare Il Mulino di Amleto è il volume edito da Cue Press dedicato alla compagnia fondata da Barbara Mazzi e Marco Lorenzi
Partiamo dalla fine, o quasi: risaliamo la corrente di Raccontare il Mulino di Amleto edito da Cue Press a fine 2024. Oltre alle autrici Ilena Ambrosio e Laura Novelli, è numeroso e qualificato il gruppo di specialisti riuniti attorno al lavoro della compagnia fondata da Barbara Mazzi e Marco Lorenzi. C’è l’intervento del ‘nostro’ Mario Bianchi, che racconta in una prospettiva autobiografica il proprio percorso di spettatore a fianco di quello della compagnia, per il quale rimanda anche a un’intervista a Lorenzi, ancora presente su queste pagine. C’è il resoconto degli anni da ufficio stampa di Raffaella Ilari e l’attenta disamina di Renzo Francabandera, che esplora dal punto di vista della multimedialità il linguaggio del Mulino. C’è il saggio di Laura Bevione intorno all’approccio che la compagnia, di lavoro in lavoro, ha mantenuto con la letteratura drammatica, «controcorrente in un’epoca segnata dal postdrammatico». Il lavoro di Mauro Sesia esplora poi il Marco Lorenzi didatta, che non si esaurisce nella pratica sempre attiva del training con gli attori degli spettacoli ma si specializza nell’attività come direttore artistico del master internazionale per attori e attrici LoStudio, in cui l’artista incarna perfettamente il ruolo di «regista maieuta».
Procedendo ancora a ritroso nel libro, ma rimanendo nella seconda parte, quella dei materiali e degli interventi, prima di una serie di ricordi di collaboratori storici della compagnia, è presente una zona che configura una «costellazione lemmatica», un nucleo di parole attorno a cui Lorenzi e Mazzi si interrogano, sollecitati dalle curatrici. Ora riflettono su «ricerca» («vocazione alla ricerca» è quella che riconosce in sé Lorenzi, condotta contro la «castrazione preventiva», data dall’artista, «dall’assuefazione ai limiti morali, economici e strutturali, che conduce l’artista a non porsi neanche più il problema del nuovo, del rischio, del superamento dei confini»); su «compagnia» («in una vera compagnia si può arrivare a momenti di anarchia, la vera anarchia, quella che utopisticamente sarebbe bellissimo esistesse nel mondo», dice Mazzi); su «incontro», «progettualità» e «umanesimo».
L’approccio e la tensione umanistici del Mulino di Amleto si evincono non solo dal racconto che ne fa Enrico Pastore nel suo racconto di Cantiere Ibsen, il progetto – interrotto dal Covid – in cui proprio alle ristrettezze e alle assuefazioni si è cercato di porre una barriera, di costruire un’alternativa, ma sono evidenti anche nella prima parte del libro.
Qui, nel cuore del volume, si esplora il rapporto della compagnia con il testo e la letteratura drammatica, a partire dalla scelta dell’opera da mettere in scena: quanto diverse sono le «piattaforme» de Gl’innamorati di Goldoni rispetto a Mahagonny, all’Affabulazione pasoliniana, all’estratto dal film Festen, a Čechov, Hugo. Si passa poi a esaminare il lavoro sul testo, l’attore nel contesto del Mulino, il dispositivo scenico, e infine il pubblico, in una quasi ininterrotta catena di coblas capfinidas, ove il titolo di un capitolo riprende l’ultima parola del precedente. E insomma, oltre un linguaggio pronto a trascolorare a contatto con testi e contesti diversi, tutto trova un senso e un ordine nel caro vecchio nucleo caldo del metodo (o il non-metodo), nelle sue radici. Radici che affondano, innanzitutto, nell’ultimo Stanislavskij, quello per cui «la vita fisica conduce alla vita spirituale», e non viceversa, e che apre dunque, in prospettiva, alla pratica del training e, risalendone le origini, dell’etjud, che Vasil’ev rinominava, sulla scorta di Marija Knebel, «metodo dell’analisi attiva», cioè condotta «per mezzo dell’azione». E poi in Peter Brook, quello che forse rimane il principale nume tutelare di Lorenzi, dalla cui idea di uno spazio vuoto «come strumento» si procede in un avvicinamento graduale alla «modalità ‘ecosistemica’ di pensare l’ambiente scenico». E nella definizione di Katie Mitchell di «idee rilevanti» del testo, attraverso le quali costruire il concept: come ci ricordano Novelli e Ambrosio con le parole della studiosa inglese, «qualcosa che il regista impone al testo» e con cui «lo interpreta scenicamente».
Analisi attiva, spazio come strumento, idee rilevanti: tutti concetti attivamente coinvolti, come si vede, a frantumare la separazione tra testo e scena, anzi a inserirli nella dialettica che è, in fondo, la regia nel suo senso più profondo e più nobilmente artigianale, in cui la teoria è sempre tesa alla prassi, anzi alle prassi.
Ed è questo ciò che consente, come ricorda Alessandro Toppi (in conclusione del volume, con un ultimo intervento che illumina tutto il percorso di una luce larga, che sfora sul contesto) di «affrontare i testi classici come fossero contemporanei e i testi contemporanei come fossero classici».
È un intervento, quello di Toppi, che lega l’idea di un percorso lungo, come quello pensato da Mazzi e Lorenzi, ad esempio, col Cantiere Ibsen, ma frequentato in occasione di ogni nuova produzione, alla realtà di una politica e di un’amministrazione che, negli ultimi anni, si è interrogata sulla misurabilità dell’intervento economico pubblico sull’arte in termini di effetti, appunto, tangibili, meccanicisticamente ricadenti nella realtà.
È quanto accade in questi giorni con la pubblicazione delle graduatorie per il FNSV, da più parti lette come una decisa sterzata verso «visioni attraenti, prodotte in eccesso e subito rimpiazzabili», per citare il volume che stiamo leggendo.
Invano suonerebbero oggi le parole di Ferdinando Taviani riportate da Toppi quasi in conclusione del volume, così aderenti all’ostinato lavoro del Mulino e al rifiuto della castrazione preventiva di cui si diceva, ma così disperatamente fuori fuoco, eppure un monito alla presenza, almeno su carta, del pensiero lungo degli antichi maestri: «Il sussidio economico non serve per finanziare la diffusione del risultato raggiunto, ma appunto per permettere un processo che miri a un risultato».
Collegamenti