Logbook
Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

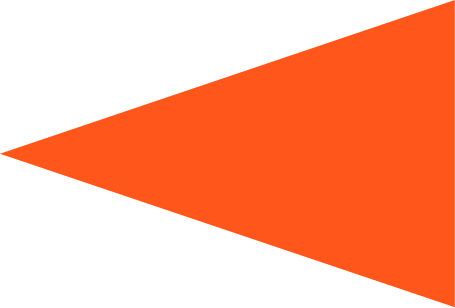
Vittorio Gassman. L’autobiografia come sfida ermeneutica
Quando nel 1981 apparve nelle librerie, l’autobiografia di Vittorio Gassman suscitò un prevedibile clamore mediatico. L’era dei social non era ancora nata, ma sulla stampa e nelle TV fu con dovizia presentata e commentata, lo stesso autore s’impegnò non poco a pubblicizzarla. A distanza di un quarantennio un piccolo ma agguerrito editore, Cue Press, ha avuto la lodevole idea di ripubblicarla, con la prefazione di Emanuele Trevi: riecco dunque tra le nostre mani Un grande avvenire dietro le spalle. Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso.
La scelta reca in sé il riverbero di un evento culturale: queste pagine, la voce trepidante che le anima, sembrano provenire da un’altra era geologica. In un’epoca di endemica dimenticanza, di vuoto annichilente e pensiero globalizzato, (ri)scoprire la storia, l’arte, la cultura di questo Paese, quali strabilianti personaggi l’abbiano popolato, è un’esperienza quasi trascendente. A renderne imperdibile la lettura non è infatti la presenza di succulenti aneddoti sul dorato mondo dello spettacolo (che pure abbondano), ma il racconto vivido e densissimo di un lungo pezzo di storia – quella di noi tutti.
Gassman si dimostra un autentico scrittore, in grado di padroneggiare lessico e sintassi, forma stilistica e struttura narrativa. Il «gioco della memoria» si lega al «diagramma degli incontri» con un ritmo travolgente, e il racconto scorre con la suggestività d’una jam session parlata, abilmente intessuto intrecciando discorso memoriale e dialogo, autointervista ed epistola, brani lirici e uso del catalogo, riflessioni saggistiche e descrizioni romanzesche, in un avvicendamento di punti di vista, di passaggi dalla prima alla terza persona. Un virtuosismo tutt’altro che manieristico, che gli permette di dare forma compiuta ai ricordi, sempre sorvegliati e legati in un continuo dialogo al presente, in una modalità tutta postmoderna di riflessione lucida sull’atto del narrare, sul suo significato, sulle sue qualità terapeutiche: «Scrivere questo libro mi ha se non altro aiutato a guarire». Suggendo avidamente queste palpitanti pagine si ha insomma l’impressione che l’autore vi abbia infuso non soltanto grande mestiere e una notevole sincerità (condita da autodenigrazioni non assolutorie: il feroce egocentrismo, la smisurata ambizione, la vanesia volubilità, una visione di sé «pesante di ombre e di impietose confessioni»), ma tutto un mondo di conoscenze artistiche, culturali e umane accumulate in una vita.
L’intento di fare i conti con il proprio vissuto appare evidente, con il proposito di porsi quale «freddo e rigoroso cronachista dei fatti andati». La modalità comunicativa è però quella dell’affabulazione arguta, del gioco intelligente e provocatorio, della sfida intellettuale con se stesso e col lettore. Sfida lanciata sin dall’incipit: «Leggete – se ne avete voglia – soprattutto la punteggiatura: virgole, punti e virgola, punti, trattini, parentesi, e anche puntini di sospensione, perché no, crepi l’avarizia…». È una vera e propria affermazione di poetica, con la quale l’autore avverte che la verità andrà cercata nel non detto, in ciò che giace tra un’affermazione e l’altra, nell’allusione e nella strizzatina d’occhi: la figura dell’ellissi come modalità per giungere (o almeno tendere) al vero. Siamo dunque nel cuore del processo artistico, venato d’una sapida e accorta ironia, dal ludo citazionistico (altro elemento fortemente postmoderno) con quel lampante rimando a Totò e alla celeberrima lettera con Peppino, dal tentativo «di dare un controllo, una distanza» al dire, pur con la consapevolezza di una possibile resa all’inenarrabile che sempre circonda l’esperienza umana, poiché in queste come in altre memorie vi sono dei buchi, dei fatti che «sfuggono al raccontabile».
Il libro si lascia comunque gustare come una frizzante coppa di champagne, con una prosa d’una tale vividezza da non far rimpiangere troppo l’assenza di materiale iconografico. È diviso in capitoli dai titoli divertenti e financo sboccati, rispecchianti le fasi della vita, intrecciati in un misurato sovrapporsi tra piani narrativi passati e il presente della scrittura – davvero non ci si annoia mai. L’autore principia dalla «ricattatoria sinfonia dei colori e degli odori remoti» della casa di Genova dove trascorse i primi cinque anni di vita, passa in agile rassegna i rapporti con la sorella Mary e con la madre (donna dall’«istinto istrionico» e figura centrale della sua vita), gli anni calabresi e quelli romani, la precoce perdita del padre, le prime cotte, le grottesche esperienze militari, i fasti cestistici (Gassman è stato un nazionale di basket), la Roma occupata e i meravigliosi aneliti di libertà seguiti alla Liberazione, l’approdo all’Accademia nazionale di arte drammatica: le esperienze e i momenti topici ci sono tutti. Così come sono «rappresentate» le tappe fondamentali della spettacolare carriera artistica, con i trionfi (molti) e i tonfi (rari), l’esordio alla regia teatrale con la messa in scena d’un indimenticato Amleto (1952), i formidabili spettacoli allestiti negli anni Sessanta e Settanta, la «rocambolesca impresa televisiva» del Mattatore (1959), il progetto «progressista» di un Teatro popolare itinerante e la lotta durissima ingaggiata con i teatri stabili e «un pubblico reazionario e moralista», il momento del «ritiro sull’Aventino» a leccarsi le ferite con feste e spettacoli organizzati nel villone di famiglia, «i pomeriggi opachi di alcol e di spleen». E, naturalmente, il contrastato rapporto con il cinema, dalla precoce «ripugnanza allora reciproca» con la macchina da presa all’amore germogliato grazie all’opera di grandi registi (tra cui Monicelli, «padre putativo» insieme allo scrittore Sandro De Feo), il tutto sapientemente miscelato con la vita privata, aspetto sul quale Gassman indulge volentieri, mettendo a nudo se stesso e le sue tante donne (tacendo o mutando qualche nome qua e là), raccontando i tumultuosi matrimoni (lunga e particolareggiata la rammemorazione di quello con Shelley Winters, con la quale intreccia un dialogo a distanza a partire dall’autobiografia di lei, raccontando anche «la storia autentica della mia ‘scoperta dell’America’»), le numerose «scappatelle», i rapporti con i mostri sacri del teatro, con colleghi coetanei e più giovani, le amicizie di una vita e quelle finite male, le manie e le inquietudini esistenziali, il complesso rapporto con i figli.
Di sommo interesse sono poi le riflessioni sul mestiere dell’attore, sull’arte scenica e cinematografica, che testimoniano un impegno intellettuale ed emotivo intensissimo, una compenetrazione assoluta tra arte e vita. E ancora, sul tremendo iato tra finzione e realtà, intimamente e soffertamente avvertito, sull’imprescindibilità del linguaggio eppure sulla sua inutilità: tra queste ed altre contraddizioni si dipana un racconto che, al pari d’una riuscita opera letteraria, getta luce sul significato dell’esistenza percorrendone le luci della ribalta ma anche e soprattutto le ombre, le zone oscure, gli anfratti più reconditi.
Insomma, neanche un rigo appare superfluo in questa sorta di postmoderno romanzo veristico truccato da autobiografia, che si chiude con dei versi scritti per la terza moglie, Diletta D’Andrea. E se anche dovesse perdere la sfida ermeneutica lanciata dall’autore, il lettore potrà comunque dare una risposta convintamente affermativa alla domanda che Gassman con piglio metaletterario si pone: «Ha un senso questo voltarsi indietro e riannodare le fila del tempo passato?».
Collegamenti
Aspettando Godot, quello vero
Tanto per cominciare, Vladimir non raggiunge Estragon come siamo abituati a pensare. È già in scena, «a destra vicino all’albero, per metà nell’ombra. Estragon è immobile, e cerca di togliersi lo stivale». Fin dalla didascalia iniziale di Aspettando Godot, Beckett sposta i suoi personaggi, ne smuove i corpi, i fonemi, le traiettorie sceniche.
È un lavoro di altissima precisione compiuto nel 1975, in occasione della messa in scena che lo stesso Samuel Beckett fece di En attendant Godot (Warten auf Godot) in lingua tedesca allo Schiller Theater di Berlino, a 22 anni dalla prima parigina dell’opera che gli procurò una fama mondiale. Le revisioni al testo per la messa in scena berlinese servirono anche per l’allestimento di En attendant Godot che Walter Asmus realizzò nel 1984 per il San Quentin Drama Workshop: dopo le prove londinesi, lo spettacolo, destinato a diventare a tutti gli effetti una produzione dello stesso Beckett, aprì l’Adelaide Arts Festival in Australia.
Oggi, grazie alla Cue Press, questo copione viene pubblicato in Italia, assieme al voluminoso corpus di note, inserti e ragionamenti che vanno a comporre una guida labirintica per chi volesse entrare nella mente di un genio al lavoro: Quaderni di regia e testi riveduti e corretti. Aspettando Godot, edizione critica di James Knowlson e Dougald McMillan, a cura di Luca Scarlini (pp. 454, € 54,99).
Su fogli a quadretti, ripristinando a tratti l’originale francese, Beckett annota le ferree dinamiche delle sue creature. All’interno di un disegno geometrico interrotto ogni tanto da furiose cancellazioni che esplodono come nuvole nere, ogni parola viene sottoposta alla verifica implacabile della scena. È soprattutto nelle didascalie che l’autore esprime la sua immaginazione plastica: silenzi ancora più prolungati, movimenti di esattezza millimetrica che includono personaggi e oggetti.
Qualche esempio? Mentre Estragon dorme, Vladimir non cammina «irrequieto avanti e indietro» come descritto nel testo originale, ma segue in direzione antioraria l’identico percorso che Estragon aveva appena compiuto in senso orario. Nel testo riveduto, Estragon non è seduto su un sasso, ma su una roccia. Migliaia di note e un unico grande scopo: «Dare forma alla confusione». Complessivamente, emerge una cartografia delle anime spoglie e del loro affannoso cercarsi e distruggersi, che l’incredibile lavoro di Luca Scarlini, curatore e traduttore, consegna agli studiosi, ai registi e ai lettori che vogliano osservare da vicino gli strumenti di lavoro dell’officina di Samuel Beckett, premio Nobel per la letteratura nel 1969. «Beckett lavorava attraverso suggestioni piuttosto che affermazioni, creando immagini che si rimandano a vicenda e risuonano nell’immaginazione» scrive nella prefazione del volume il biografo James Knowlson.
Il progetto editoriale della Cue Press non si ferma qui. Entro l’autunno verranno pubblicati altri inediti: i Drammi brevi e i Quaderni di regia relativi alle messe in scena beckettiane di Finale di partita e L’ultimo nastro di Krapp.
Il peggio degli anni Settanta in 120 film
Esotici, erotici, psicotici. Il peggio degli anni Settanta in 120 film (Cue Press) di Renato Palazzi, con prefazione di Maurizio Porro, è un viaggio tra i titoli più improbabili e controversi del cinema di quegli anni, dove il gusto per l’eccesso si mescola all’irriverenza tipica di un’epoca piena di sperimentazioni e trasgressioni.
Un libro che, tra curiosità e analisi critiche, restituisce l’atmosfera di un decennio cinematografico tanto vituperato quanto affascinante.
Collegamenti
Emanuele Trevi racconta Vittorio Gassman
Durante l’appuntamento, i conduttori dialogano con Emanuele Trevi in occasione della riedizione per Cue Press di Un grande avvenire dietro le spalle. vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso, l’autobiografia di Vittorio Gassman.
Un viaggio avvincente dall’infanzia alla vecchiaia del grande attore, arricchito dall’introduzione di Trevi, che racconta così la vitalità e l’ironia di una delle figure più carismatiche della scena teatrale e cinematografica italiana.
Collegamenti
L’agenda rossa di Beckett il revisore. Aspettando Godot in tedesco è tutta un’altra storia
È quella pettegola della moglie a riferirgli che, durante la prova generale, i pantaloni dell’attore non sono «caduti nel modo giusto». Piccato, Samuel Beckett (1906-1989) scrive al regista Roger Blin, chiedendogli che «quel gesto» venga eseguito correttamente perché fondamentale a suscitare «il riso e il pianto» nello spettatore. Accade a Parigi, nel 1953, al Théâtre de Babylone: sta per debuttare Aspettando Godot.
Che lo scrittore irlandese pretenda – dei suoi testi – regie pedisseque e precise è risaputo, ma ora arriva, coup de théâtre, la smentita, firmata dallo stesso Beckett in una già mitologica «agenda rossa»: Quaderni di regia e testi riveduti – Aspettando Godot è un poderoso volume curato da James Knowlson e Dougald McMillan (e, per l’edizione italiana, Luca Scarlini), appena pubblicato da Cue Press del vulcanico Mattia Visani.
Primo di una serie dedicata al Premio Nobel – presto arriveranno gli appunti di Finale di partita et al. –, il libro rende conto di Warten auf Godot, la versione tedesca di Aspettando Godot, riveduta e corretta nel 1975, a ventidue anni dalla prima, per lo Schiller Theater di Berlino, dove l’autore firma anche la regia. «Dando forma alla confusione», Beckett rimaneggia il canovaccio sin nel sottotitolo, aggiungendo lo spiegone Una tragicommedia in due atti, ma anche vivacizzando i dialoghi con intercalari secchi e ripetitivi – «Ah sì», sic – dall’indubbio effettaccio comico. Forse ha poca fede nell’umorismo teutonico, e «forse» – a detta dei curatori – è proprio «la parola chiave del suo teatro e della radicale incertezza della pièce… Per Beckett chiunque si scopre ‘un non-sapiente, un im-potente’».
Sotto il bisturi dello spietato doc Samuel, Aspettando Godot in tedesco sembra tutta un’altra storia, ma solo se ci si concentra sulle minuzie (il sasso, non la roccia, su cui si siede Estragone, ad esempio): ottime per i filologi, perniciose per i teatranti. Dopotutto, sono gli stessi curatori ad ammetterlo, quest’opera «non è (nonostante gli sforzi da parte di alcuni critici di farla sembrare tale) un pamphlet filosofico con una spruzzata di teatro». Semmai il contrario; un copione per palcoscenico con sbuffi di esistenzialismo e vaghe ambizioni suicidarie: «Ci impiccheremo domani. A meno che non venga Godot». Seee.
Una domenica con Beckett e Scarlini
Per la prima volta in Italia, vengono pubblicati i quaderni di regia di Samuel Beckett.
Durante la trasmissione, si approfondisce la genesi di questi materiali, mettendo in luce le ragioni che spinsero l’autore a curare personalmente la messa in scena delle proprie opere e evidenziando le differenze rispetto alle versioni precedenti.
Si analizzano le motivazioni del notevole ritardo con cui i lavori di Beckett sono stati rappresentati in Italia, soprattutto se paragonati alla loro diffusione nei maggiori Paesi europei.
Collegamenti
Dire luce
Il testo offre una doppia visuale sulla tematica specifica della luce in scena, ovvero, un’osservazione bilaterale proveniente da una studiosa e da un professionista dello spettacolo. Cristina Grazioli, sia nell’attività didattica presso l’Università di Padova che nella copiosa produzione scientifica, ha indagato con particolare attenzione i rapporti tra scena e arti visive con approfondimenti specifici alle questioni riguardanti la luce. Pasquale Mari è light designer e direttore della fotografia, impegnato da molti anni in campo teatrale e cinematografico (e nelle arti visive in generale) in ambito internazionale, svolgendo anche attività di docente di progettazione luci (all’accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico così come in corsi e master specializzati). E dunque il punto di vista si compone dell’analisi specifica di un aspetto poco presente negli insegnamenti di Discipline dello Spettacolo nelle università italiane e dell’esperienza di un artista che ama definirsi «operario della luce», rivendicando un primario valore artigianale al suo lavoro.
Il titolo, che deliberatamente cita la traduzione italiana di una raccolta di Maria Zambrano (Dire luce. Scritti sulla pittura, a cura di Carmen del Valle, Bur-Rizzoli, Milano 2013), annuncia la complessità che risiede nel tentativo di definire l’elemento luce, qui declinato per le esigenze della scena (con particolare riferimento a quella teatrale, nonostante la presenza di esempi riferiti al set cinematografico), attraverso parole e definizioni possibili. «Dire luce» non indica solo la volontà di definire al meglio l’oggetto della riflessione, ma traduce la necessità di conferire alla luce la stessa centralità di significato solitamente attribuita alla parola. Allo stesso tempo, il dialettico scambio tra le differenti prospettive degli autori sottolinea che la limitazione di senso manifestata dall’elemento verbale rispetto al suono che la definisce (soglia puramente acustica che schiude una infinita ricchezza di significati possibili), corrisponde alla medesima difficoltà di esprimere il dato luminoso in relazione alla sua impalpabile ma pervasiva presenza. Emerge quindi la centralità di una sostanza immateriale ma concreta, invisibile eppur presente che, mentre riguarda e definisce la vita reale, diventa segno linguistico dominante sulla scena.
L’introduzione di Cristina Grazioli, guida necessaria alla lettura, informa che il testo prende forza da progetti pregressi realizzati con l’università di Padova: Teatro botanico. Incontri alla luce dell’Orto botanico (2014), Dire luce. Le parole e le cose che illuminano la scena (progetto dipartimentale 2018-2020), Lumière de spectacle (in collaborazione con Université de Lille e Centre d’Étude des Arts Contemporains). Le suggestioni scaturite dalle tappe segnalate (che hanno coinvolto istituzioni, studiosi e artisti di varia provenienza), si essenzializzano nel volume nella necessità di un discorso tra due voci che appaiono subito in sintonia. Un’intesa che, esito fortunato di rinnovate collaborazioni, testimonia soprattutto la complementarità tra un creatore di luce da sempre impegnato ad ampliare gli orizzonti stessi del mezzo utilizzato e una studiosa la cui formazione conduce naturalmente all’organizzazione dei fenomeni in un ambito storico-artistico. Le rispettive competenze, nutrite da un elevato numero di situazioni artistiche e occasioni didattiche vissute insieme o singolarmente, mettono in rete una fitta serie di riferimenti ad altri ambiti disciplinari che hanno il pregio di rimandare il lettore a continui approfondimenti sollecitati anche da un solido e raffinato apparato iconografico.
La struttura prescelta nell’articolazione del testo si compone di dodici voci sulle quali gli autori si confrontano con puntuale successione. Ma i rispettivi punti di vista sono alimentati da conoscenze tecnico-scientifiche, letterarie, poetiche, pittoriche, teatrali, cinematografiche e musicali che derivano da prassi operative che hanno fortemente caratterizzato i profili professionali degli autori che qui emergono mediante un differente atteggiamento analitico. Frequenti sono, ad esempio, i rimandi a spettacoli e film realizzati da Mari con numerosi registi internazionali (Mario Martone, Andrea De Rosa, Kriszta Szekeli, Marco Bellocchio, Ferzan Ozpetek), così come ricorrono opportune citazioni a mostre e installazioni oggetto di reiterati studi condotti in Europa da Cristina Grazioli.
Le dodici parole individuate corrispondono a caratteristiche, comportamenti, contesti applicativi o semplicemente orizzonti simbolico-concettuali che riguardano la luce. Non obbedendo ad alcuna logica consequenziale, l’alternanza costruita per ogni punto consente un’arbitraria scelta nella selezione delle letture nella costruzione di un personale percorso di indagine. Le voci trattate sono: Invisibilità, Materia, Scrittura, Polvere, Buio, Colore, Movimento, Voce, Trasparenza, Atmosfera, Botanica, Aria. A dispetto di un’apparente frammentazione, i termini rivelano subito una relazione reciproca, ovvero, una coralità complessiva che delinea la luce come pratica inclusiva nella quale ognuna delle dodici riflessioni comprende inevitabilmente le altre.
Assunto di base, che affiora in filigrana in ogni sezione, è la considerazione della luce quale dispositivo capace di attivare, in maniera spesso inconsapevole, lo sguardo di un osservatore. Quando sulla scena la vista si trasforma in attenzione e colui che guarda diventa uno spettatore, l’occhio è orientato da una serie di elementi che solitamente si individuano per lo più in macro-elementi quali il testo, la scenografia, l’attore con il carico del suo dominio espressivo. In questo processo la luce, come realtà fisica trasversale, è investita di una responsabilità pari a tutte le componenti presenti nello spazio, fissata e veicolata in una immagine viva capace di imporsi come stupore. Si sottolinea così da un lato l’importanza del ruolo del progetto luci per la scena, luogo dove si incontrano il mondo della tecnica e quello dell’arte, in grado di agire sulle facoltà percettive dello spettatore; dall’altro la necessità di alimentare l’attenzione sull’argomento specifico sul versante degli studi teatrali.
Occorre però segnalare che la ricchezza degli esempi che gli autori riportano nelle pagine, sia sottoforma di citazioni di eventi artistici che nella veste di indicazioni bibliografiche contenute nelle note, testimonia un incremento dell’attenzione delle ricerche sulla luce condotte negli ultimi decenni. L’ampiezza dei riferimenti rende pertanto il volume particolarmente prezioso per il lettore interessato che, mentre entra nel vivo delle questioni volta per volta suggerite, entra in possesso di una mappa aggiornata dei contributi critici su scala internazionale. È però significativo che a tale aggiornamento facciano da sfondo testi e pratiche fondative, più volte evocate, dei padri del Novecento teatrale (quali George Fuchs ed Adolphe Appia, per citarne qualcuno), o di autori drammatici per i quali la luce è portatrice di senso nel suo essere anche buio e non il suo opposto (come il pluri-evocato Beckett). Esperienze, queste, che hanno fortemente direzionato un atteggiamento esplorativo, sperimentale, aperto ai linguaggi che, come un fiume carsico, giunge fino ad oggi.
L’immagine che complessivamente si staglia dal dialogo è quella di «paesaggio artistico»: si tratta di un’esperienza culturale e conoscitiva che include in termini di risorsa le alterità, le espressioni divergenti, le opposizioni, le anomalie. In questa estensione del concetto la luce attraversa e sostanzia il paesaggio, tessuto connettivo di un’esperienza comunitaria che accoglie la dialettica degli elementi nella dimensione del chiarore naturale, «luce condivisa» alla quale si fa riferimento soprattutto in relazione ad originali esperienze nelle quali il percorso artistico guarda all’aperto, intessendo rapporti virtuosi tra teatro e natura, teatro e giardini (si veda a proposito la parte dedicata al Teatro Botanico pp. 168-183).
La voce finale, ARIA, chiude in maniera ideale il percorso con la consegna di una visione in divenire, lungimirante, di necessaria disponibilità. Gli autori producono infatti un’immagine bifronte nella quale la luce si impone come forza che sostanzia l’aria e questa, a sua volta, diventa energia propulsiva che direziona la luce.
Entrambe le dimensioni si distinguono, ancora una volta, per essere immateriali nella loro presenza totalizzante, confermando la scena come luogo attivo e, al contempo, spazio di libertà dove la luce è aria vitale. Alla densità delle riflessioni presenti nelle dodici sezioni, e alla suggestiva scelta della voce finale, si aggiunge il valore contingente del tempo di realizzazione del prodotto editoriale. Com’è chiarito nell’Introduzione, il volume prende forma definitiva durante i mesi asfittici del lockdown, quando la possibilità di vivere a contatto della luce naturale e fare esperienza dell’aria hanno assunto la statura di un desiderio primario, quasi irraggiungibile.
Collegamenti
Il teatro sociale e le arti performative
Claudio Bernardi fu il primo, nel 1998, a utilizzare la definizione «teatro sociale» per indicare un insieme in realtà piuttosto composito di pratiche teatrali aventi finalità educative, formative, inclusive e comunque non estetico-professionali. Quella «etichetta», però, conteneva in sé anche esperienze risalenti a decenni precedenti rispetto a quello oggetto dello studio di Bernardi che, insieme a Sisto Dalla Palma, diede inizio a un’analisi non episodica né generica di questo particolare settore delle arti performative.
Giulia Innocenti Malini si colloca proprio sul sentiero aperto dai due studiosi e, forte della duplice veste di ricercatrice e operatrice, traccia una sintetica ma esaustiva cronaca critica della nascita e del variegato sviluppo del teatro sociale nella nostra penisola, a partire dai primi episodi di teatro fuori dal teatro ovvero di laboratorio non finalizzato a spettacolo, sulla scorta dei movimenti contestatari e del magistero grotowskiano, e dalla fondamentale avventura dell’animazione teatrale. Il capitolo centrale del libro è dedicato, però, al trentennio che va dal 1978 al 2008 e che segna il progressivo moltiplicarsi di progettualità e di pratiche ormai consapevolmente appartenenti a un fare teatro esterno, tanto fisicamente quanto negli obiettivi e nelle forme, rispetto alla scena tradizionale. Una crescita esponenziale di esperienze che non si è interrotta negli anni successivi, convincendo l’autrice a indicare, per il periodo 2008-20, alcune linee di tendenza, esemplificate da alcuni casi paradigmatici. Nel complesso, il volume testimonia la vitalità di un settore delle arti performative che, al di là dei precipui obiettivi «sociali», pare capace di generare nuovi codici e stimolare fertili riflessioni pure nel teatro propriamente detto.
Ostrovskij e la nascita del teatro nazionale a Mosca
È stato il drammaturgo che ha tracciato un solco profondo nell’Ottocento russo, ancora oggi viene regolarmente messo in scena nei più grandi teatri del Paese e considerato il padre del teatro moderno, ma in Occidente in pochi lo conoscono. Eppure Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij (1823-86) ha segnato la vita del teatro della sua epoca in Russia più di ogni altro, perché i vari Puškin e Gogol di «professione» facevano altro, erano cioè narratori e per le scene scrivevano saltuariamente. Lui invece mise in cantiere più di cinquanta opere che diventarono spettacoli di successo, contribuendo anche a una nuova organizzazione teatrale. Nominato membro della Commissione per la riforma dei teatri ha un chiodo fisso in mente, quello di far nascere un teatro nazionale a Mosca, e, quando è scelto per la condirezione dei teatri imperiali, vede l’obiettivo a portata di mano: peccato che tutto ciò accada poco prima della sua morte e quindi l’idea resta solo un bel sogno. «Perché le pochissime messinscene all’estero passano nell’indifferenza generale? Molte sono le ragioni, tutte valide e nessuna convincente», afferma Fausto Malcovati nella splendida, ricchissima introduzione ai due volumi pubblicati da Cue Press e dedicati ad alcuni dei maggiori testi del drammaturgo, un’operazione impreziosita dal lavoro attento e originale di una squadra di traduttori che riportano la scrittura di Ostrovskij a un ritmo e una musicalità meritoriamente contemporanei. Malcovati dà una serie di spiegazioni convincenti del fatto che questo autore sia finito (in buona compagnia) nell’ampio limbo dei dimenticati al di fuori del Paese di origine: l’arretratezza della società russa del tempo, e poi la lingua, così diversa da quella dei grandi classici e per molti versi bizzarra e scomposta. Segni, attuali anche oggi, della necessità di costruire la società su nuove basi.








