Logbook
Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

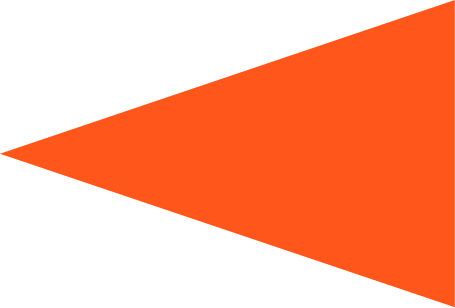
Dedicato a chi crede che scrivere un monologo sia facile. Intervista di Marina Cappa a Josep Maria Miró
Qualche giorno fa, mentre stava sbarcando dall’aereo a Firenze, una telefonata gli ha annunciato che aveva vinto ventimila euro. I soldi contano, anche per gli scrittori. Ma ben di più pesa stavolta il valore artistico di questo Premio nazionale della letteratura drammatica 2022.
Il ministero della Cultura spagnola lo ha assegnato a Josep Maria Miró, scegliendolo fra diverse centinaia di autori che avevano pubblicato nell’ultimo anno un testo di drammaturgia.
Il suo era Il corpo più bello che si sia mai visto da queste parti. Qualche mese fa – al Teatro Rifredi di Firenze, in anteprima mondiale – Maddalena Crippa diede appunto «corpo» a questo «testo per unico interprete (a sette voci)», che ricostruisce una morte e un incontro.
Adesso Miró è tornato a Firenze, sempre al Teatro di Rifredi diretto da Giancarlo Mordini, in occasione della presentazione del suo ultimo spettacolo: L’amico ritrovato, adattamento del libro di Fred Uhlman che in passato era stato sceneggiato per il cinema da Harold Pinter.
Per l’occasione ha partecipato anche alla presentazione del nuovo libro in cui Fabio Francione (per la serie Scheiwiller Sguardi sul teatro contemporaneo) intervista 16 protagonisti del teatro contemporaneo, fra cui appunto lui.
L’autore è catalano e i suoi testi sono tradotti in diverse lingue, compreso lo spagnolo. Ha 45 anni, scrive (fra i suoi lavori più noti, Il principio di Archimede e Nerium Park) ma dirige anche, regista di opere non necessariamente sue.
Attivo fuori dalle scene, Josep Maria ha raccontato di essere pure andato a un convegno di Vox per fotografare i partecipanti, che si sono subito tolti la maglietta per esporre toraci e muscoli. Non che gli uomini politici siano meno narcisi dei loro seguaci, è convinto. Come ha spesso osservato: la loro presenza nelle sale cinematografiche o teatrali si nota solo quando fuori li aspettano un red carpet, fotografi e televisioni, e dichiarazioni a uso auto-promozionale.
Restiamo in tema: per lei, fare teatro è fare politica?
Tutto è politica, vivere è politica. Il teatro lo è perché è un incontro di spettatori che condividono uno sguardo sul mondo, con posizioni uguali oppure diverse, e l’occasione di mettere in dubbio le proprie posizioni e il sistema intero in cui vivono. In teatro noi rinnoviamo il nostro patto di convivenza e i nostri principi. Anche quando si tratta di spettacoli di puro intrattenimento. Pure questa è un punto di vista politico, anche se conservatore.
Che cosa vede quando guarda oggi all’Italia?
Quello che succede è preoccupante, non solo in Italia ma anche nel Nord Europa, in Francia, in Spagna: mi tocca, non è qualcosa di esterno a me. Oggi alcuni partiti che sono ai margini della democrazia sono usciti dall’armadio, non si vergognano di mostrarsi. Ma è inquietante anche che altri partiti democratici, o che si dicono tali, abbiano permesso loro l’ingresso nelle istituzioni, attraverso patti, accordi. Senza dimenticare il quarto potere, la stampa, che ha fatto loro la campagna.
Il ruolo dell’artista qual è, allora?
Deve essere cronista del suo tempo, raccontarne la complessità, generare riflessioni, dubbi. Mai dogmi, però. Un artista può esprimersi in migliaia di modi diversi, ma l’importante è farlo sempre con una visione etica.
Lei in alcuni casi scrive testi che saranno diretti da altri, a volte invece è regista di se stesso. Che differenza c’è nell’approccio? Non ha paura di essere «tradito» o di «tradire»?
Ho avuto molte esperienze, felici e meno. Quando affido un mio testo a qualcuno sottoscrivo con lui un patto di fiducia, ed è vero che negli ultimi anni sono diventato un po’ geloso, cerco maggiori garanzie. Quando invece dirigo il lavoro di un altro – e ne ho fatti diversi – mi metto al servizio di quel materiale e posso farlo solo se ci credo, anzi dopo un po’ finisce che credo di averlo scritto io quel testo. In ogni caso, io scrivo il teatro che mi piacerebbe vedere, tradimento per me significherebbe scrivere pensando solo alla reazione del pubblico.
Non vorrebbe dedicarsi alla narrativa?
Da tempo lo vorrei fare, ma ho sempre molti dubbi su me stesso, non so se ne sono capace. Ma prima o poi verrà il momento. Il corpo più bello che si sia mai visto da queste parti è il mio primo monologo, un editore lo ha letto e ha detto che sarei pronto.
Non aveva mai scritto monologhi prima?
No, spesso si crede che questa sia la forma teatrale più semplice, ma non è così. Lo puoi scrivere dopo che hai affinato gli strumenti di scrittura, le idee. C’è un’età per ogni cosa, come per gli attori: non puoi fare Re Lear o Giorni felici se non hai una certa esperienza alle spalle. Uno dei vantaggi degli anni che avanzano è che si perde l’ansia di fare tutto subito, di ottenere risultati: adesso prendo molto più sul serio ciò che faccio e sono più cosciente del perché scrivo.
Che cosa la spaventa di più nel provare la narrativa: la storia, i dialoghi?
Come dico sempre ai miei corsi di Drammaturgia, il teatro è un genere molto complesso; quando lo scrivi devi sempre tenere in considerazione la teatralità. Però poi lo monti su un palco, assieme ad altre persone e scopri la sua efficacia, sperimenti, puoi togliere battute, correggere qualcosa con gli attori: si sperimenta mentre lo fai e c’è un lavoro di équipe. Nella narrativa tu sei solo, il riscontro te lo dà solo l’editore, che è un altro mondo ed è un vincolo molto importante, tante carriere letterarie sono dipese da lui. Quando il libro è finito, e già questo mi sembra richieda molto più tempo, si pubblica: l’esposizione al pubblico è un salto nel buio. Ma ammetto che sono tutte scuse per ritardare qualcosa che finirò per fare.
I premi, come questo che ha appena vinto, aiutano?
Fanno piacere. Ma – premi o non premi, successo o non successo – ogni volta che ti metti a scrivere una cosa nuova, ricominci da zero. Lo spettatore in teatro non vedrà le tue statuette e gli applausi che hai ricevuto: vedrà quello spettacolo nuovo, e lo giudicherà. Questo è meraviglioso e terribile al tempo stesso. Anche molto adrenalinico, perché in teatro l’esperienza non è garanzia di nulla. Ogni volta sei messo alla prova. E ti devi confrontare non solo con gli altri drammaturghi, ma anche con te stesso, con quello che hai fatto prima e che ti potrà essere giocato contro.
Il suo rapporto con il Teatro di Rifredi dura da tempo…
C’è un rapporto umano e artistico straordinario. Anche con gli spettatori. Rifredi ha creato un pubblico fedele, ha costruito un’identità in cui lo spettatore si riconosce. Come succede con le librerie. Puoi averne una grossa, dove il commesso impara due cose e ti suggerisce l’ultimo romanzo, quello che piace a tutti, vende molto… Dall’altra parte, c’è il negozio magari piccolino dove il libraio ti consiglia l’opera giusta proprio per te. Questo è il Teatro di Rifredi.
Collegamenti
I dieci anni di Cue Press al fianco di teatro e cinema
Scommettere sull’editoria teatrale è un vero e proprio azzardo. A dieci anni di distanza dalla nascita della casa editrice Cue Press, la scommessa sembra essere vinta, ma con tutte le cautele che impongono il presente e soprattutto il futuro. «A pensarci bene non avrei mai immaginato di festeggiare il decennale di Cue Press, che per me rimane una bel- la avventura e una scommessa tutt’ora – afferma Mattia Visani –. L’idea iniziale è stata quella di lavorare su una casa editrice digita- le, in cui il prodotto editoriale fosse soprattutto online, uno sviluppo che credo abbia ancora ampi margini».
Nelle parole di Visani c’è la consapevolezza che, dopo il lockdown dei teatri a causa del Covid, si prepari una nuova ondata di crisi: «Malgrado ciò siamo in espansione, la nostra politica editoriale piace, forse perché si costruisce con le relazioni con gli artisti e i teatri, senza dimenticare la necessità di coltivare la memoria degli studi che hanno fatto la storia della cultura teatrale, non solo in Italia – continua l’editore -. Ad esempio, stiamo lavorando per dare alle stampe la riedizione del saggio di Ludovico Zorzi, Il teatro e la città, ormai introvabile. Abbiamo fatto così per altri volumi o per alcuni autori. Si è trattato di un modo per rendere disponibili saggi e testi ormai irreperibili». Al di là della necessità di ridare vita, e quindi mercato, a libri di saggistica teatrale e cinematografica, c’è l’attenzione alla drammaturgia contemporanea italiana e straniera, e il progetto Quaderni di regia e testi riveduti di Samuel Beckett ne è un esempio. «Lavorare sui quaderni di Samuel Beckett è stato ed è il nostro più grande impegno editoriale soprattutto per la mole di materiali – afferma Visani –. Credo che sia la più importante novità editoriale nell’ambito delle pubblicazioni legate allo spettacolo, insieme al volume Il teatro postdrammatico di Hans-Thies Lehmann. Le due operazioni editoriali per noi hanno avuto un valore non solo imprenditoriale, ma anche simbolico: hanno dimostrato la vivacità di un’editoria di nicchia, ma che sa essere molto ricettiva e attiva nel proporre e nel germinare idee».
In questo senso si lega anche l’attenzione che nell’ultimo periodo la casa editrice sta dedicando al mondo del cinema: «Dall’autobiografia di Vittorio Gassman, al saggio di Goffredo Fofi e Gianni Volpi dedicato a Vittorio De Sica, piuttosto che a quello di Leif Zern, Vedere Bergman, o al testo di Renato Palazzi, Esotici, eroti- ci, psicotici. Il peggio degli anni Settanta in 120 film, il cinema è diventato un settore importante per Cue Press che sta dando grande soddisfazione – continua Visani –. Detto questo, l’attenzione ai testi teatrali e alla pubblicazione di drammaturgie legate a nuove produzioni è fondamentale e soprattutto è il bello di questo mestiere. Il mettersi a disposizione di attori e teatri per fermare su pagina scritta esperienze, estetiche, testi e drammaturgie dà il senso del nostro lavoro, sottrae il teatro all’effimero, ci permette di agire non solo come casa editrice, ma anche come un progetto culturale che testimonia quanto accade nel teatro italiano e, nei casi più felici, si fa promotore di nuovi stimoli culturali».
Nelle parole di Mattia Visani, che profumano di bilancio e di considerazione per capire come reinventarsi e costruire un piano di sviluppo, non manca la considerazione che «la casa editrice prima del Covid aveva fatto registrare un incremento di crescita pari al 68%, questo per far capire che cosa lo stop pandemico abbia interrotto – prosegue l’editore –. Solo per fare un esempio, il mese di giugno scorso abbiamo fatturato un terzo rispetto al mese precedente e la metà rispetto al 2021. Malgrado questi segnali, credo che Cue Press possa ancora intercettare una fascia di mercato come quella legata allo spettacolo che è in parte sguarnita, dopo la fine di alcune importanti e gloriose case editrici di settore. Certo, stampare libri – il volume cartaceo ha il suo fascino e non tramonta, anzi – oggi è un azzardo, ma noi siamo convinti che questo azzardo premi e ce lo testimoniano gli artisti che si affidano a noi».
Nelle parole di Mattia Visani coesiste la volontà di dare vita a pubblicazioni che contribuiscono alla scoperta di autori come Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij, con la preziosa collaborazione di Fausto Malcovati, oppure che fermino su carta il magistero di Giorgio Strehler nel centenario della nascita, o ancora raccontino il volto privato di Bernard-Marie Koltès nella pubblicazione delle sue lettere. Ma nel catalogo di Cue Press ci sono anche i giganti della drammaturgia contemporanea non solo italiana, basti pensare ai testi di Pascal Rambert, Sergio Blanco, Juan Mayorga oppure Tim Crouch, solo per fare qualche esempio, cui si affiancano gli italiani da Saverio La Ruina, a Daniele Timpano, a Emanuele Aldrovandi, a Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, anche qui la lista è più che mai incompleta. La casa Cue Press festeggia il suo decennale con un forte senso di realtà, consapevole di un orizzonte non facile, ma altrettanto convinta che oggi pubblicare libri – in cartaceo e in versione digitale – non solo sia un servizio, ma rappresenti un modo per fare cultura insieme agli artisti e ai teatri.
Milo Rau, Realismo globale
Che il Teatro sia o possa essere non solo aristotelica mimesi/rappresentazione ma soprattutto uno strumento per cambiare il mondo è oggetto di una riflessione antica che nella modernità si è fatta spesso più consapevole. Come l’alchimista sanguinetiano, il facitore di teatro combina in maniera singolare gli elementi della rappresentazione per produrre una materia estetica nuova da cui sprigionare un’energia che travalica, con la quarta parete, i confini della scena per entrare di diritto tra le forze in campo, dentro le dinamiche attraverso e quali il mondo «si fa» e si evolve. Milo Rau è forse l’artista che più di ogni altro progetta di organizzare ed utilizzare con più consapevolezza questo strumento/teatro, rendendo in qualche modo esplicite le leggi, o meglio le regole implicite, che lo strutturano. Cerca cioè di abbinare la riflessione estetica con la fattiva operatività, in una reciproca condivisione ed influenza di cui il cosiddetto «Manifesto di Gent» (coevo all’assunzione della direzione del teatro di quella città) è espressione dialettica. Da questo «Manifesto», che chiude il volume di cui trattiamo, citiamo in proposito due illuminanti affermazioni: «Il primo passo verso il ‘teatro di città del futuro’ è quindi trasformare le regole implicite in regole esplicite», la prima; «Non si tratta soltanto di rappresentare il mondo. Si tratta di cambiarlo», la seconda. Il libro dunque raccoglie ed anticipa le ragioni di queste conclusioni, attraverso una raccolta di conversazioni sul teatro con critici e studiosi, e con la riproposizione di alcuni testi e discorsi, chiusa appunto con il citato «Manifesto di Gent». La pubblicazione, infine, è introdotta da una partecipata prefazione/presentazione di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari che riconoscono in Milo Rau alcuni degli elementi del loro essere nel teatro, con alcuni punti che si possono percepire sovrapponibili con momenti del loro, più liricamente motivato, «Teatro Politttttttico». Un volume che è una sorta di autopresentazione di uno degli autori più noti e anche controversi del teatro mondiale di oggi.
Collegamenti
Graces Anatomy. Dai corpi al testo
A Lamezia Terme, Calabria tirrenica e centrale. Tra le province di Cosenza e Catanzaro, a un respiro dalla Costa degli Dei, probabilmente una delle più incantevoli d’Europa. Nella terra di ‘ndrangheta, evitando piagnistei dal sapore della commercializzazione dei dolori a fini di persuasione (pratica diffusa in regione), un presidio culturale, sociale, etico, punto di riferimento per ogni strato sociale.
Tutto pronto per realizzare il bando. Si pensa a Silvia Gribaudi, danzatrice – a stringere la divaricazione tra vocazione e proposta (la passione di Dario Natale per la danza, il ribadire la potenza dei nuovi linguaggi) – l’idea è del laboratorio aperto, professionisti e neofiti, un osservatore critico. E poi il Covid. Il lockdown. La scappatoia: realizzarlo in streaming. Graces Anatomy, a cura di Sandra De Falco, per la penna di Michele Di Donato, edito da Cue Press (69 pagine, € 14,99) è letteralmente il diario di bordo di quella esperienza.
Introduzione di Dario Natale e Domenico D’Agostino (Scenari visibili), in postfazione il resoconto dei partecipanti, parola a chi precedentemente aveva usato il corpo. Emozioni vivide, incanalate e costrette e perciò liberate in meccanismi puri di espressione. La rappresentazione a significare movimenti intimi tradotti in gesti, tentare di incarnare l’irrappresentabilità del presente vivo. La penna di Di Donato, sensibile auditore, pennella a guazzi d’acquerello, descrive a rigore di cronaca e verseggia coinvolto nella partecipazione. Quaranta performer, l’oggetto immaginifico del pensiero tradotto. Un’opera scultorea di riferimento: Tre Grazie, di Antonio Canova, «un nuovo ordinamento degli spazi dettato dai corpi».
Alcune foto prima di calare il sipario, postcards di un remoto tornato a galleggiare. Si fa inconsueta testimonianza, il volumetto, di vissuti umani in situazioni altre da cosa è convenzionalmente accettata come quotidianità. E di come l’arte, qualora ancora ci fosse bisogno di ribadirlo, si sovrapponga ai responsi di anima e psiche settati in modello seriale. La liberazione dei corpi, rianimati quali tracce di linguaggio, di presenza, di comunicazione, di relazione con l’altro. Un pezzo immancabile, nelle biblioteche teatrali.
Collegamenti
Compito del teatro, fin dalla sua nascita è stato quello di relazionarsi con l’Altro
Secondo Claudio Bernardi, il Teatro Sociale non era altro che la «nuova frontiera della scena internazionale», da intendere come una summa del potere relazionale. In verità, si può affermare che compito del teatro, fin dalla sua nascita, è stato quello di utilizzare il palcoscenico per mettersi in relazione con l’Altro, evidenziando la sua funzione sociale che, però, è ben diversa dal vivere una relazione di tipo sociale.
Il Teatro Sociale, a cui fa riferimento Giulia Innocenti Malini nel volume, pubblicato da Cue Press, è un «genere» che si afferma, nel secondo Novecento, durante la rivoluzione sessantottesca, la stessa che registrò la nascita di forme teatrali alternative a quelle degli Stabili che perseguivano il carattere artistico e, pertanto, estetico nelle loro produzioni.
Tra i nuovi generi, il Teatro Sociale si occupò di relazioni, senza però ricorrere con continuità alle esigenze della messinscena e del palcoscenico tradizionale. C’è da dire che, su questo argomento, ha lavorato molto l’Università Cattolica attraverso una serie di ricerche pubblicate sulla prestigiosa rivista Comunicazioni sociali; e attraverso gli studi di Bernardi, Cuminetti, Dalla Palma, Cascetta. In questa sede insegna Giulia Innocenti Malini, che è anche Operatrice e Coordinatrice del corso di Alta Formazione per Operatori nel Sociale. Cercare le origini di questo genere è il traguardo a cui tende l’autrice, convinta che, al di là degli obiettivi artistici o estetici, il Teatro Sociale possegga altri meriti che esercita con metodologie diverse, in particolare nel campo terapeutico ed educativo, da cui sono derivate delle discipline come la Teatroterapia, l’Educazione alla teatralità e il Drama-therapy, crogiolo di parecchie attività performative che utilizzano il gioco, il rito, la festa, il ballo, utili per creare delle interazioni che permettano al Teatro Sociale di intervenire nelle comunità, nei gruppi e persino nei singoli che soffrono forme diverse di disagio nelle case di cura, nelle scuole, nelle periferie, nei campi profughi, nelle carceri. Sulla spinta di questa necessità nacquero il Teatro di Animazione, che ebbe in Franco Passatore il suo punto di forza, esercitato nelle scuole o negli ospedali psichiatrici, ed ancora il Teatro di Base, i cui operatori diedero il loro apporto, anche politico, alle esigenze delle masse popolari.
Ci si imbatte in esperienze eterogenee, libere da esigenze professionistiche e proiettate verso l’essenza primordiale del teatro, sempre più concepito come Laboratorio, con obiettivi non artistici, ma terapeutici e pedagogici. Si tratta di Laboratori diversi da quelli di Grotowski o Barba, citati dalla Malini come fonte ispiratrice di un lavoro che verrà esplicato con attitudini diverse, perché fuori dal teatro, onde venire incontro a chi ne avesse bisogno.
Forse, il modello più giusto è quello di Giuliano Scabia con le sue «Azioni teatrali», con l’uso di grandi pupazzi per rappresentare i problemi delle nuove generazioni e la «disumanità» della vita metropolitana, pupazzi che facevano il verso a quelli di Peter Schuman e del «Bread and Puppet», con i suoi complessi spettacoli di strada. Di Scabia, inoltre, bisogna ricordare il suo lavoro accanto a Franco Basaglia e l’esperienza di Marco Cavallo, nata come opera collettiva e integrata dalla partecipazione degli stessi ammalati, con un lavoro molto approfondito, come quello di Armando Punzo nelle Carceri di Volterra, anche se esercitato con maggiore volontà e voluttà artistica.
L’autrice divide il suo lavoro in tre periodi, quello dello Stato nascente, durante il ventennio 1958-78, quello del Periodo rivoluzionario che coincide con gli anni 1978-2008, per concludere con alcune considerazioni che riguardano il presente, dove manca qualsiasi riferimento al lavoro svolto da Nanni Garella con i pazienti della USL di Bologna, con i quali, dopo lunghi percorsi di formazione, ha realizzato alcuni spettacoli, fra i quali il bellissimo Fantasmi (2002), primo abbozzo di Pirandello dei Giganti della montagna, con notevoli risultati artistici, che ebbe grande successo di pubblico e di critica, con i malati applauditi come veri e propri attori. Se vogliamo citare ancora un grosso nome, anche Robert Wilson nel 1968 si conquistò la fama di «terapista» sperimentale per il suo lavoro con un sordomuto e un malato di cerebropatia, per i quali creò delle vere e proprie pièces teatrali.
Dalla Grecia arcaica alla Grecia di Pericle, il dualismo è arrivato ai giorni nostri
Esistono dei periodi e delle culture che sono contrassegnate dalla «scrittura» orale e altri che vedono l’affermazione della scrittura letteraria; entrambe utilizzano la parola con finalità narrative o teatrali. Possono essere, in generale, caratterizzate da periodi più o meno brevi, come accadde nella Grecia antica, prima dell’avvento di Pericle, quando la recitazione orale si contrassegnava come fenomeno di gruppo, oppure da periodi più lunghi, quando la scrittura permetteva che la recitazione fosse un’operazione di tipo individuale.
Com’è noto, la trasmissione orale si era caratterizzata anche per la sua capacità di trasmettere il sapere, grazie alla presenza dei poeti che la trasformarono in generi teatrali, come la tragedia e la commedia. C’è da dire che la trasmissione orale avveniva in spazi liberi che davano soltanto l’idea della scena, dove si esibivano gli Aedi e i Cantori, inventori, a loro volta, della parola come «Azione parlata», che fa venire in mente un saggio giovanile di Pirandello, dallo stesso titolo; azione parlata che, con altri stratagemmi, dovuti all’invenzione dei dialoghi e alla partecipazione del Coro, veniva ereditata da Eschilo, Sofocle, Euripide, con la sola differenza che trattavasi di quella particolare parola poetica che, appena detta, diventava azione, senza ausilio di apparati scenografici.
A dire il vero, questo trapasso si verifica in tutte le culture delle origini, come sarà, per esempio, quella medioevale, quando nacque la tradizione orale ad opera dei Trovatori, prima dell’avvento della grande poesia trecentesca, a cominciare dalla Commedia di Dante. Se poi vogliamo ancora indicare, in tempi più ravvicinati a nostri, una nuova cultura delle origini, bisogna partire dagli anni Settanta, quando cominciò ad affermarsi il Teatro dell’Oralità.
In un volume, pubblicato da Cue Press: Lingua orale e Parola scenica. Risorsa e testimonianza a cura di Vera Cantoni e Nicolò Casella, l’argomento viene trattato con una serie di brevi saggi che mostrano un andamento storico, pur se con qualche indagine spuria che riguarda autori come Chekov, Beckett, Jelinek; per i quali Fausto Malcovati, Tommaso Gennari e Roberto Nicoli — sostenendo che in alcune loro opere si avverte un rapporto con il linguaggio orale, da cui deriverebbe, in parte, la loro scrittura — ricercano elementi che, appunto, possano far pensare a una pseudo oralità, dovuta a certi innesti presi dalla tradizione popolare. Il bisogno dell’oralità, a parte quella «primaria», di cui ha scritto Walter Ong, avviene quando chi scrive per il teatro avverte momenti di stasi, se non di regresso della lingua scritta che, a sua volta, necessita di una linfa vitale che può esserle data da un uso particolare della comicità o dei vari dialetti. Pietro De Sario fa riferimento, per esempio, all’oratoria politica, dalla forte componente orale, presente nell’Ecclesiazuse di Aristofane, mentre Giorgia Bandini evidenzia le «ricorsività foniche» presenti nei Menecmi di Plauto.
Come detto sopra, non potevano mancare gli interventi sul Teatro dell’Oralità, in particolare quello che fa uso di forme dialettali, come accade in Marco Paolini, Gaspare Balsamo, Emilio Isgrò; e ancora, all’uso di «Lingue nuove», a cui ricorrerebbe Federico Tiezzi quando porta in scena testi non teatrali. Il ricorso all’uso dei dialetti non è del tutto nuovo, ma si è reso necessario quando intende dimostrare come la profonda ricchezza fosse dovuta alla capacità, insita in loro, della trasmissione orale, proprio perché contengono componenti non scritte, ma verbali, che risentono della tradizione orale che diventa, a sua volta, una vera e propria risorsa di quella scritta. Questa derivazione è maggiormente presente quando si ricorre al «Cuntu», come fa Gaspare Balsamo e altri cuntisti.
Oggi assistiamo a un fenomeno di quella che, sempre Ong, definisce «oralità secondaria», tipica di una nuova era liminale, dove la scrittura è contaminata dall’uso dell’elettronica che permette all’espressione verbale un maggior coinvolgimento, dovuto a ben noti apparati tecnologici ed elettronici che spesso nascondono, grazie agli alti volumi sonori, pratiche effimere e, a volte, dilettantesche. Il volume contiene anche un «Cantare» di Giuliano Scabia: Nella voce a passo di fiato.
Orsini regala un finale a Ivan Karamazov
Un finale. Sì, un finale per Ivan Karamazov. Dostoevskij non lo ha scritto. Nel romanzo tutti i personaggi ne hanno uno: Mitja parte per i lavori forzati con Grušenka, Alëša progetta un futuro con i ragazzi che ha riunito per i funerali di Iljuša. Tutti tranne lui. L’ultima sua apparizione è nell’aula del tribunale dove si svolge il processo per il parricidio. Ormai in preda alla febbre cerebrale in cui lentamente sprofonda, vuole scagionare il fratello. «Non è lui che ha ucciso nostro padre, è Smerdjakov. Ha confessato, ma non può testimoniare, poche ore fa si è impiccato». Nessuno gli crede: farnetica, dicono, è malato. E scompare. Di lui non si sa più nulla. Sì, ci vuole un finale per Ivan Karamazov. Ci ha pensato Umberto Orsini, mitico Ivan dello sceneggiato di Sandro Bolchi, anno 1969. Chi non lo ricorda, biondissimo, quasi albino, gli occhiali rotondi, l’aria concentrata? «Me lo sono inventato io quel trucco. Cercavo la fisionomia di un intellettuale perplesso, di un figlio inquieto di quegli anni tragici (nello stesso anno della pubblicazione del romanzo lo zar Alessandro II viene ucciso dalla bomba di un terrorista). Da allora non ho mai abbandonato quel personaggio. Ce l’ho dentro, è diventato il mio doppio, il mio sosia. Ci sono tornato una decina d’anni fa, portando in teatro il lungo monologo del Grande Inquisitore. Attualissimo. Sconvolgente nella sua lucidità.»
Sì, è lui che ha inventato il finale, insieme al regista Luca Micheletti. Le memorie di Ivan Karamazov (Cue Press), sarà in scena dal 4 al 16 ottobre al Piccolo Teatro Grassi di Milano in prima nazionale. Un lavoro lungo, complesso, sorprendente, un montaggio in cui si intrecciano discorsi di Ivan, battute inventate, frammenti di altre opere di Dostoevskij (per esempio il celebre attacco di Memorie dal sottosuolo, «Sono un uomo cattivo…»), voci di altri personaggi che irrompono, si accavallano, si innestano nell’aggrovigliato flusso di coscienza del protagonista.
Ivan vuole concludere la sua vicenda di allora, vuole giustizia, quella giustizia che ha fallito per causa sua. È solo con la sua coscienza, con la sua storia, con i suoi fantasmi, con le sue ossessioni. È passato un secolo, forse di più, due, tre. Ivan è vecchio, «mi hanno dato per disperso ma sono ancora qui, sono ancora vivo». Ricompare nell’aula di quel tribunale dove per l’ultima volta si era presentato. Tutto intorno è distruzione, rovina, caos, disfacimento, degrado, documenti stracciati, carte sparpagliate ovunque, registri sfasciati. Come se fosse passata una bufera, come se i secoli avessero rimescolato, ingarbugliato, sconquassato tutto. In questo paesaggio corroso, sgretolato dal tempo, lui, Ivan, si aggira, vuole ricostruire la sua storia, vuole dire la sua verità, esige la sua sentenza, chiede ascolto, attenzione, giustizia, come se la sua vita cominciasse dopo la sua scomparsa. Si racconta, e nel discorso si affollano i suoi incubi. Primo fra tutti il diavolo, quel diavolo meschino, banale, petulante, presuntuoso che gli è apparso nell’ultima notte prima della sua devastante deposizione in tribunale: è il suo doppio malvagio, e qui torna a provocarlo, a intralciare i suoi discorsi, a ricordargli i suoi errori, eterno principio del male, alleato e nemico.
«Nello sceneggiato di Bolchi avevamo inventato una soluzione che sottolineava il suo essere la mia coscienza sporca: io dicevo le battute di Ivan e la mia voce registrata diceva le battute del diavolo. Come in fondo vuole Dostoevskij, il diavolo non è altro che il me stesso volgare, il mio sottosuolo turbolento, provocatore, categorico. Anche qui lo aggredisco, lo scaccio, cerco di annullarlo, vorrei strangolarlo ma lui rispunta continuamente a ricordarmi la mia ambiguità, la mia colpa, la mia mancanza di fede. Sì, perché uno dei grandi temi del romanzo è proprio lo scontro tra chi accetta Dio e chi lo rifiuta. C’è un breve scambio di battute tra il beffardo Fëdor Karamazov, padre lascivo, perverso, il cerebrale Ivan e il mite Alëša, proprio sull’esistenza di Dio: un dialogo che abbiamo voluto inserire perché ci sembrava importante per definire lo scetticismo di Ivan. ‘Dio esiste?’, mi chiede mio padre. ‘No, Dio non esiste’, rispondo. ’Dio esiste, Alëša?’. ’Sì, padre, esiste’. ‘Ivan, l’immortalità esiste? Un’immortalità qualunque, anche se piccolissima, minuscola?’. ‘No, neppure l’immortalità esiste’. ‘Di nessun tipo?’. ’Di nessun tipo’. ‘Cioè lo zero assoluto, il nulla? Ma ci sarà almeno qualcosa, sarebbe meglio del nulla!’. ’Zero assoluto’. Ecco, in questo zero assoluto c’è tutto Ivan, l’ateo, il negatore. È una componente fondamentale del mio personaggio che riappare secoli dopo. Ancora il nulla, ancora il vuoto. Ed è per questo che lo ripropongo oggi nello spettacolo la Leggenda del Grande Inquisitore. Anche qui abbiamo trovato un espediente per renderla attualissima e insieme lontanissima: un vecchio fonografo, uno strumento antidiluviano che trasmette la mia interpretazione del 1969. Non tutto il testo, ovviamente, che è lunghissimo, solo i frammenti più forti, più aggressivi, più categorici. A questo proposito voglio raccontare un episodio che mi riguarda, sempre dello sceneggiato del 1969. Diego Fabbri, autore della riduzione, aveva previsto per quella scena uno sdoppiamento, una sorta di dissolvenza in cui scompare la stanza dove sono io e, con un cambio di costume, divento il Grande Inquisitore, con parrucca e tonaca. Mi rifiutai. È Ivan che inventa questo personaggio tremendo, algido, glaciale, perché togliergli la responsabilità di raccontare quella leggenda? È lui che ci guida nell’implacabile requisitoria del vecchio Inquisitore contro Cristo, interlocutore muto, imputato impassibile, presenza-assenza, capace solo di un bacio finale ‘sulle vecchie labbra esangui dell’Inquisitore’. E l’ho spuntata. Mi sono assunto la responsabilità dell’intero monologo, nessun taglio, nessun arrangiamento, le sessanta pagine del copione tutte d’un fiato. Si è deciso di dedicare un’intera puntata, un’ora e passa di trasmissione: sembrava interminabile e invece ha appassionato gli spettatori di allora.»
Certo il tema del Grande Inquisitore appassiona Orsini. «L’ho voluto perché è un momento fondamentale nell’ideologia di Ivan, il contestatore, il cattivo maestro che rifiuta ogni fede ma insieme rifiuta ogni azione.» Un tema che non ha tempo, che pone interrogativi all’uomo di allora come all’uomo di oggi. Ecco dunque il senso dello spettacolo: spingere gli spettatori a ragionare su questioni troppo in fretta accantonate o troppo semplicisticamente risolte. Questioni che invece premono ancora, disturbano ancora. Che cos’è la religione oggi? Qual è il vero insegnamento di Cristo? Quanto c’è di formale, abitudinario, esteriore nei nostri atti di fede? Ci domandiamo mai se la nostra non sia una devozione svuotata del senso profondo di quello che diciamo, ripetiamo, ascoltiamo? Obbediamo forse solo a comodi precetti stabiliti dalla Chiesa, da tutte le chiese, che poco hanno a che fare con l’autentico insegnamento evangelico? Il Grande Inquisitore, quando ha di fronte il misterioso predicatore che ha fatto arrestare perché troppo popolare, lo riconosce, non ha dubbi, è il Cristo reincarnato nella Spagna dei processi, dei roghi, degli autodafé e gli dice: vattene, hai detto secoli fa quello che dovevi, non abbiamo più bisogno di te, disturbi il nostro sistema solido, concreto.
Ecco la modernità, la lucidità delle pagine dostoevskiane: che cosa hanno fatto le chiese, l’ortodossa come la cattolica, se non rendere meccanico, asfittico l’insegnamento del Cristo? Norme, dogmi, precetti, regole, costrizioni, imposizioni. Il contrario di quello che ci dicono i Vangeli: Cristo ha dato all’uomo la libertà, la possibilità di scegliere, di autodeterminarsi. Ma l’uomo non vuole la libertà, troppo impegnativa, troppo scomoda. Un tema che a Orsini sta molto a cuore. Vuole, con il suo spettacolo, ricordare agli uomini: abbiate il coraggio di essere liberi, non cercate sottomissione, obbedienza, consenso, rifiutate il conformismo, siate autonomi da leggi che riducono il vostro libero arbitrio. E invece il Grande Inquisitore lo sa: l’uomo ha paura della libertà, troppo complicato valutare ogni gesto, cercarne la giustificazione, meglio che qualcuno decida per lui. Ecco il grande dilemma dell’uomo da secoli: più facile delegare che assumersi responsabilità, più facile seguire il gregge che difendere le proprie scelte, accettarne le conseguenze, positive o negative, felici o dolorose che siano, più facile l’acquiescenza che la rivolta. Dice Orsini: «Lo spettacolo si apre con una citazione evangelica, che è anche l’epigrafe del romanzo: ‘In verità, in verità vi dico: se il chicco di frumento caduto nella terra non muore, resterà solo, ma se muore, allora produrrà gran frutto’. Credo che queste parole siano importanti, perché ci aiutano a capire il percorso di Ivan, la sua solitudine, la sua inquietudine, la sua rivolta. Sì, Ivan è un chicco che non muore, che non dà frutto, che resiste, che rifiuta, è un ribelle, un contestatore, un sovversivo. Rifiuta il mondo così com’è, divorato da ingiustizie, discriminazioni, violenze. Si sofferma soprattutto sulla sofferenza dei bambini. Perché un innocente deve soffrire, se non ha commesso alcun peccato? Perché esistono uomini che violentano, stuprano, torturano piccole creature inermi, pure, candide? No, dice Ivan, questo mondo io non lo capisco, non lo voglio, lo rifiuto, mi ribello, protesto, prendo le distanze e restituisco il biglietto d’ingresso. Ma se rifiuta la creazione, allora rifiuta anche il suo Creatore. E senza un principio superiore che guidi le azioni degli uomini, allora ‘tutto è permesso’. Frase famosissima che è la vera molla del personaggio Ivan. Tutto è permesso, dunque non ci sono limiti, non ci sono freni, non ci sono ostacoli ai comportamenti umani. È una frase che risuona più volte nello spettacolo: è un monito ai ribelli, ai chicchi che non muoiono, perché tra la libertà del tutto è permesso e la depravazione non c’è più linea di demarcazione. Dunque anche il delitto è permesso. Una teoria che Smerdjakov afferra, fa sua, e uccide. Ma c’è un confine al ‘tutto è permesso’, un confine che Ivan non esplicita, tralascia, ma matura nel tempo: di ogni atto, anche il più perverso, bisogna avere il coraggio di assumersi la responsabilità. Cosa che non fa Smerdjakov: pur di non confessare si suicida. Ivan non lo farà mai: nonostante il suo rifiuto del mondo, ama la vita a dispetto della logica, ama ‘le foglioline vischiose, che spuntano a primavera, il cielo azzurro, certe persone, senza sapere il perché’; ha sete di vita, di passioni, nonostante tutto, di condivisione. E nella conclusione dello spettacolo c’è proprio la confessione di Ivan: Smerdjakov ha ucciso, ma il vero assassino sono io. Io che ho istigato, ho autorizzato, ho acconsentito, dunque condannatemi. Chiede, ormai vecchio, quella giustizia che gli è stata negata da giovane, perché nessuno gli ha creduto. Una giustizia che lo metta di fronte alle sue responsabilità, che condanni le parole oltre che i gesti. ‘Solo allora ci sarà la pace, solo allora il chicco morirà e darà gran frutto, un giorno o l’altro, con il tempo…’. Chiudo con questa battuta sul tempo, il grande nemico… Eccolo il finale che manca, che l’autore non ha scritto: la vecchiaia di Ivan, che capisce di avere parlato troppo e male, e che tuttavia ama la vita e attende la morte.»
Le parole… le parole possono anche uccidere. In questi tempi di infiniti sproloqui, di incessanti chiacchiericci, di assordanti dichiarazioni, Orsini con il suo spettacolo ci mette in guardia. Le parole hanno un peso, una forza, una penetrazione nelle coscienze che troppo spesso sottovalutiamo. Stiamo attenti. L’attrazione per gli slogan sensazionali, per le teorie a effetto, può avere conseguenze incalcolabili. Lo spettatore si porti a casa le crisi, le inquietudini, i tormenti, la protervia di Ivan, ma anche la sua ansia di pace, di serenità. E non dimentichi che siamo tutti un po’ Ivan, che lo ammettiamo oppure no.
Renato Palazzi, Esotici, erotici, psicotici
Delizioso, divertente, delicato il libro di Renato Palazzi, critico teatrale del «Sole 24 Ore», scomparso il 7 novembre del 2021, un mese prima di vedere pubblicato questo volume edito da Cue Press, il cui titolo è tratto dal film Esotika, Erotika, Psicotika del regista tedesco Radley Metzger con gli aggettivi posti al plurale.
Avvisa Palazzi ad inizio libro: «In un primo momento avevo pensato di raccogliere e ristampare queste recensioni, uscite sul ‘Corriere della Sera’ tra il 1974 e il 1978 in una forma quasi privata, per far sorridere gli amici. Poi rileggendole, mi sono reso conto che forse non ci sarebbe troppo da sorriderne».
E il perché lo chiarisce lo stesso Palazzi quando dice che — lui pischello, assunto da poco nel maggior quotidiano italiano — non poteva ribellarsi a quel piccolo caudillo responsabile delle pagine degli spettacoli che lo obbligava a recensire film di quart’ordine, perché se c’era un pubblico era giusto scriverne.
Un modo di pensare che equivaleva a sottomettere il sessantottino Renato, a reprimere la sua libertà intellettuale, non pensando che lui era stato assunto per recensire spettacoli teatrali e non film trash, inghiottendo fiele quando alle due del pomeriggio doveva infilarsi al Tonale o al Diamante o in altri cinema di Milano, vergognandosi quasi se qualcuno lo riconosceva e starsene seduto accanto a degli anziani guardoni che andavano in sollucchero. Un’esperienza traumatizzante al punto da non fargli più mettere piede in una sala cinematografica per tanti anni.
Scrive Maurizio Porro in prefazione: «Da bravo cronista Renato non si limitava a recensire in poche righe questi prodotti tutti squallidamente uguali, per cui ogni volta era lo stesso florilegio di aggettivi, ma osservava il contesto, si accorgeva se i clienti fissi passavano in toilette oltre i tempi medi della prostata e se la fila delle poltrone tremava in sensorround anche senza effetti speciali».
La scelta dei film recensiti si basa sulla possibilità di catalogarli all’interno di filoni o tendenze del momento. Così nel «Voyeurismo casereccio» incontriamo Il pavone nero, fumettone erotico-turistico avventuroso; La minorenne con Gloria Guida, impegnata a reclamizzare le più svariate marche di biancheria intima; ci viene incontro La soldatessa alla visita militare Edwige Fenech che si porta dietro Il vizio di famiglia; l’ex “baby doll” Carrol Baker dà Lezioni private di musica in una città di provincia; La bolognese è una pellicola che certamente non parla di tortellini e tagliatelle; Martine Brochard è impegnata in Quel movimento che mi piace tanto. L’adolescente è una commedia alla siciliana ricca di corna, fallocrazia e sensi infiammati; Lo stallone tiene fede alla premessa indicata, Ilona Staller appare in Inhibition, Il compromesso erotico è un revival di Don Camillo alle prese con una Peppona di sesso femminile; il regista teatrale Josè Quaglio è protagonista de La verginella e s’avverte in tutte le pellicole una dissacrazione della commedia all’italiana che continua con La dottoressa sotto le lenzuola, sgangherato revival di Amici miei con scherzi cretini da festa della matricola. Sabina Ciuffini, valletta di Mike Bongiorno, esibisce le sue grazie pudiche in Oh, mia bella matrigna, la «strehleriana» Erica Blanc mostra le sue sinuose beltà nella Portiera nuda; La cameriera nera è un film senza trama e senza idee con Femi Benussi e Le calde notti di Caligola non ha niente a che vedere col Caligola di Tinto Brass. Gli altri filoni riguardano western di terza categoria, poliziotteschi strampalati, horror d’accatto e non mancano gli alieni e mostri vari; Bruce Lee e dintorni, pugni e fagioli, coppole e lupare, nazional-popolari, furtive lacrime, effetti collaterali e alcune immagini riprodotte su manifesti colorati. Scrive Cristina Battocletti in chiusura di libro: «Film ignobili in cui Palazzi riusciva comunque a esercitare un’azione civile, perché le sue stroncature mantenevano la professionalità e il pudore della gentilezza di fronte alla spazzatura, senza desistere mai dal fornire con una manciata di parole sferzanti, un ragionamento e una serie di collegamenti che probabilmente erano ignoti perfino al regista».
Bob Wilson in Italia
Nella lunga militanza di critico teatrale, Gigi Giacobbe ha maturato la paziente ricerca dei moventi e delle estetiche tipiche dei soggetti da lui studiati. Dalle prime rappresentazioni in Italia, ha seguito con passione l’artista statunitense, rilevando l’originalità geniale delle sue creazioni, come nota Dario Tomasello nell’Introduzione. La «fedeltà» del critico offre un bilancio sull’opera scenica di Robert Wilson, mentre ne ricostruisce un primo completo e inedito ritratto: Viaggio in Italia: articoli e recensioni agli spettacoli, è il capitolo centrale del saggio.
Dal primo incontro, con Alice (di Lewis Carrol, 1994), all’ultimo, Jungle book (di Rudyard Kipling, 2022), Giacobbe unisce sagacia e affetto nel ricostruire impressioni e dati scenici su quell’opera cangiante e imprendibile, eppure così concreta. La documentazione è preziosa nel definire l’autore-regista, sia mediante le formulazioni proprie, sia valendosi di Interviste e d’altri contributi circostanziati. E le tante occasioni trovano varianti e spunti critici coinvolgenti l’intera carriera dell’americano. Per le Orestiadi di Gibellina (1994), il critico si sofferma sulla creazione del poema di Eliot, La Terra desolata: «[Wilson] Non punta sulla biografia del poeta angloamericano. Il suo intento è quello di entrare nella testa di Eliot […] penetrare i momenti creativi del poeta» (p. 26). Poi indica chiaramente immagini e figure che pullulano nello spazio allestito e animato dalla luce, coglie i ‘tre contigui spazi’ che connotano il cocktail party dell’omonima commedia eliotiana e chiude con l’immagine d’un «fiorire di teste di bambino, tutte uguali e tutte di bianco gesso.»
In Hamlet a monologue (1995) Wilson mostra che «Amleto è solo un sogno […]. Una solipsistica creatura che poco prima di morire ripercorre i vari stadi della sua esistenza. Un personaggio sfaccettato, indefinibile e oltremodo misterioso».
A Taormina, per il Premio Europa (1997), si rappresentava Persefone, sapiente e magistrale per l’impiego delle luci: «La luce del fondale muta di colore e gli azzurri, i rossi e gli arancio ne evidenziano le silhouettes come in un negativo fotografico […]. Le musiche di Rossini e di Glass, iterative e continue avvolgeranno gli interpreti sino alla fine […]. Cinque scene, pregne di elementi scultorei e atmosfere surreali, un mondo degli inferi che lascia posto, infine, a un immenso mare di luce salvifica» (p. 31).
In La maladie de la mort (1997) emerge «uno stile, quello della Duras, che abbraccia in pieno quello di Wilson, dove il tempo e lo spazio sembrano glacializzati. Uno spettacolo pittorico come è consuetudine del regista texano, durante il quale, in questa nuova Hiroshima di fine millennio un uomo [Michel Piccoli] e una donna [Lucinda Childs] provano disperatamente ad amarsi». Il quadro scenico e musicale creato da Robert Wilson e Hans Peter Kuhn per Saints and singing (di Gertrude Stein) è strutturato in prologhi, paesaggi, nature morte, e ritratti.
Una forma complessa che mira alla semplicità delle componenti linguistiche e all’armonia degli elementi teatrali: parole e spazio, movimento e silenzio, ombra e luce. «Un attore e un’attrice di cinema, francesi entrambi, Philippe Leroy e Dominique Sanda, che recitano in italiano La donna del mare, del norvegese Henrik Ibsen, totalmente riscritto dall’americana Susan Sontag e messo in scena alla sua maniera dal texano […]. Il pregio maggiore è il modo in cui Bob Wilson ha trasformato un dramma naturalistico in uno completamente antinaturalistico, surreale e sognante insieme. Utilizzando genialmente la sua scatola di illuminotecnica su una scena nuda con solo quinte nere.»
Variazioni su temi e immagini tornano nel dramma di Büchner: «Questo Woyzeck di Wilson è forse uno dei suoi spettacoli più belli, applauditissimo a più riprese sino alle ovazioni finali. Il merito va ripartito con le suggestive musiche di Tom Waits e Kathleen Brennan in grado di emozionare e condurre lo spettatore nella labirintica mente del protagonista, le cui sue vicende sono raccontate per schegge e frammenti nell’arco di due ore» (Roma, 2002).
A Spoleto (2008), l’Opera da tre soldi, di Brecht e Weill è accolta come «spettacolo di travolgente bellezza… con i formidabili attori-cantanti del Berliner Ensemble. Spettacolo memorabile di cui Wilson firma pure le splendide scene astratte e reinventa l’ennesimo disegno di luci che solo lui sa rendere magiche». Le creazioni si susseguono. Ancora a Spoleto (2009) un doppio Beckett, Giorni felici (con Adriana Asti) e Ultimo nastro di Krapp (con Wilson attore): «Wilson utilizzando i costumi e il trucco di Jacques Raymond e la drammaturgia di Ellen Hammer, interra quella donna di mezza età, nel primo tempo sino alla vita e nel secondo sino al collo, dentro una sorta di piccolo Stromboli o Etna, originato da un’eruzione d’una strada asfaltata.»
A Pompei e a Vicenza, Oedipus (2018), ripreso da Sofocle, rievoca le atmosfere con cui fu inaugurato il Teatro Olimpico nel 1585. In Jungle book, di Kipling (Firenze, 2022) permangono mistero e semplicità, poiché Wilson – provocato dalla domanda: «Jungle book è un musical?» – ripete le sue sintesi inarrivabili sull’opera «totale»: «Le etichette sono fuorvianti. Considero tutto il teatro musica e vedo tutto il teatro come danza. Questo è ciò che significa la parola ‘opera’. Racchiude ogni forma d’arte.»
Roberto Andò, in Postfazione, sottolinea le componenti essenziali di quell’opera e riconosce al libro il senso e il merito d’una «autobiografia del critico militante attraverso le creazioni di un grande visionario della scena». Le ragioni e i commenti del critico, infatti, formano un tessuto denso e coerente con gli intenti dell’artista, quasi opera o prova autonoma, in continuo mutamento. La Biografia e la Teatrografia chiudono necessariamente il bel volume.








