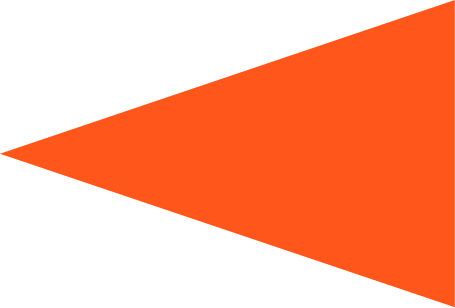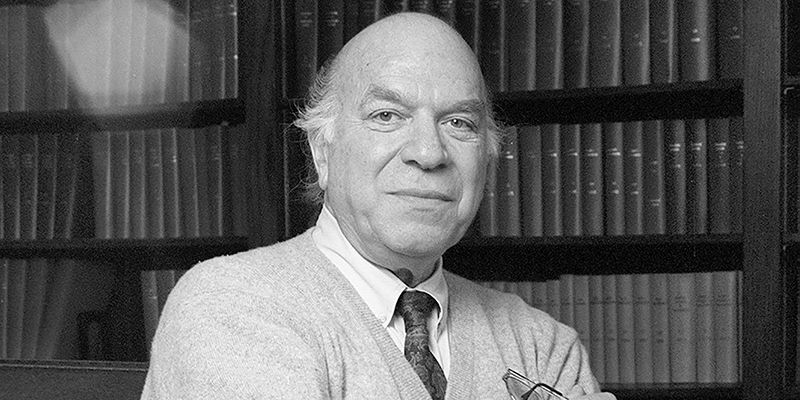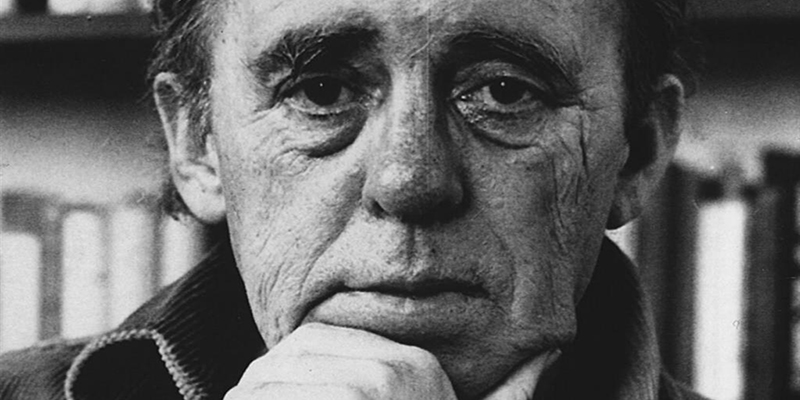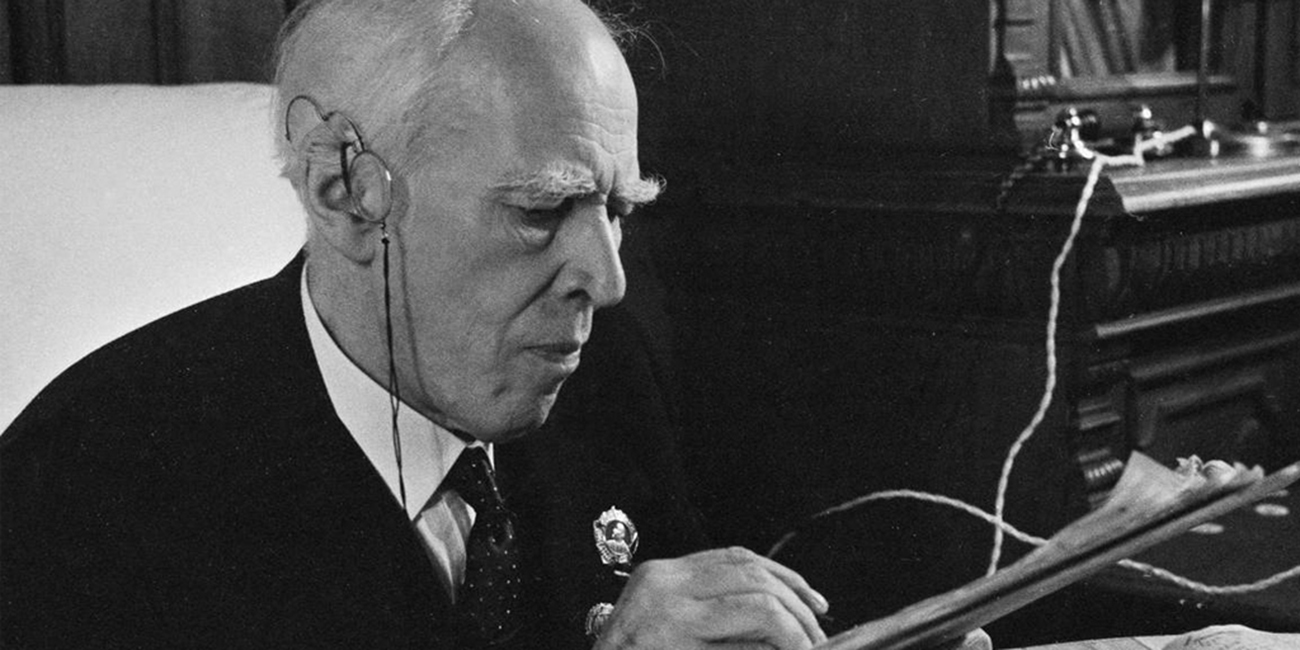Da qualche anno il pensiero versatile e multiforme di Stanley Cavell (1926-2018) sembra essere al centro di una significativa riscoperta, soprattutto sul versante dell’impegno di Cavell come filosofo estremamente interessato alle arti. Senza alcuna pretesa di completezza, come segni di questa recente opera di riscoperta è possibile citare qui, ad esempio, i volumi di Rex Butler, Stanley Cavell and the Arts (2021), David LaRocca, Music with Stanley Cavell in Mind (2024), Paola Marrati, Understanding Cavell, Understanding Modernism (2025), tutti editi da Bloomsbury, o anche il volume antologico di W. Rothman, Cavell on Film (2005¹; 2025²), edito da SUNY Press. Rientra all’interno di una tale operazione, indubbiamente significativa e meritoria, anche la recente pubblicazione in italiano, da parte della casa editrice CUE Press, di due importanti scritti Cavell dedicati al cinema, ovvero Alla ricerca della felicità. La commedia hollywoodiana del rimatrimonio (ed. it. a cura di P. Donatelli; con contributi di P. Donatelli, G. Manzoli, E. Morreale, 2022) e Il mondo visto. Riflessioni sull’ontologia del cinema (ed. it. a cura di P. Donatelli; Postfazione di G. Manzoli, 2023). È precisamente su quest’ultimo testo, ovvero Il mondo visto, che mi concentrerò in questa recensione, al fine di tentare di far emergere sinteticamente alcune linee guida dell’originale e stimolante approccio filosofico al cinema delineato da Cavell.
Uscito in prima edizione inglese nel 1971, e successivamente in una seconda edizione inglese ampliata nel 1979 (con l’aggiunta dell’importante saggio conclusivo «Ancora su Il mondo visto», meritoriamente incluso nell’edizione italiana del libro), Il mondo visto di Cavell viene presentato ai lettori e alle lettrici del nostro paese in una ricca edizione che comprende anche un’Introduzione di Piergiorgio Donatelli (pp. 8-21) e una Postfazione di Giacomo Manzoli (pp. 258-262). I due testi degli studiosi italiani risultano perfettamente bilanciati e complementari fra loro, riuscendo a far emergere in modo immediato e molto chiaro come l’ontologia del cinema di Cavell possa risultare egualmente stimolante per gli studiosi e le studiose di filosofia con un interesse per il cinema come possibile oggetto di indagine, da un lato, e per gli studiosi e le studiose di cinema con un interesse per la filosofia come possibile metodo di indagine, dall’altro lato.
Passando ora a una rapida analisi della forma e dei contenuti principali del libro di Cavell, possiamo dire, per prima cosa, che Il mondo visto si struttura in 19 capitoli di differente lunghezza, preceduti da una Prefazione, una Prefazione all’edizione ampliata e un saggio conclusivo intitolato «Ancora su Il mondo visto». Nella Prefazione (1971) Cavell prende le mosse dall’importanza del «bisogno di intrattenimento» (pur aggiungendo che esso «non è mai stato tutto, o la parte importante, di ciò che i film fornivano, così come non è tutto ciò che i romanzi o la musica forniscono») e dal proprio rapporto intimo, personale, essenziale con il cinema: più precisamente, con un certo tipo di cinema, ovvero con la «continuità con i film di Hollywood» che viene analizzata in Il mondo visto proprio in un’epoca in cui, come scrive Cavell, «Hollywood stessa [la] stava perdendo» (p. 31). È, quest’ultimo, un presupposto fondamentale alla base dell’intera indagine di Cavell, il quale, in Il mondo visto, si interroga filosoficamente sul cinema anche al fine di «rendere conto della [sua] esperienza del cinema» e del modo in cui «i ricordi del cinema si intrecciano per filo e per segno con quelli della [sua] vita» (pp. 31, 33).
Nella Prefazione all’edizione ampliata (1979) Cavell si ricollega a tale questione, accennando all’«‘onere immediato ed enorme’ che grava sulla nostra capacità di descrizione critica, quando rendiamo conto della nostra esperienza cinematografica» nel tentativo di «comprendere il medium cinematografico in quanto tale» (p. 27), e specificando come «un tema del Il mondo visto che è esplicito e guida tutta la [sua] riflessione successiva sul cinema» sia quello per cui ad «assegnare significato alle possibilità e alle necessità specifiche del medium fisico del cinema […] sono gli atti fondamentali, rispettivamente, del regista di un film e del critico (o del pubblico) del cinema», al pari dell’idea secondo cui «ciò che costituisce un ‘elemento’ del medium cinematografico non è conoscibile prima di queste scoperte della regia e della critica»(p. 27). Si tratta di un aspetto che Cavell chiama, in modo indubbiamente suggestivo, «circolo cinematografico» (in riferimento alla «reciprocità tra elemento e significato» [p. 27]) e che si collega spontaneamente, fra le altre cose, alla questione di «che cosa costituisca, o che cosa esprima, il fatto di ‘conoscere un’opera’»(p. 25).
Tutto ciò, a sua volta, non può non condurre la riflessione verso la questione del rapporto fra il cinema e altre forme artistiche, e dunque anche verso il problema, citato esplicitamente da Cavell, di «concedere al cinema lo status di soggetto che incoraggia e premia la speculazione filosofica, al pari delle grandi arti», accettando quindi «il cinema come un’arte» e, conseguentemente, non tirandosi indietro di fronte al compito di «una modifica del concetto di arte», né di fronte al compito, d’altra parte, di tracciare distinzioni tra alto e basso, o tra maggiore e minore, […] all’interno del corpo stesso del cinema» (p. 28), così come avviene spesso nel caso della pittura, della poesia, della musica o ancora altre arti. Tali questioni, a conferma della loro importanza per Cavell, vengono esplicitamente riprese anche nel succitato saggio conclusivo «Ancora su Il mondo visto” (derivante da alcuni testi presentati a un convegno dell’American Society for Aesthetics nel 1972 e poi pubblicati nel 1974), là dove Cavell spiega come «la più chiara delle [sue] intenzioni», durante la stesura di Il mondo visto, fosse quella di «dimostrare che si può scrivere sui film […] con la stessa serietà che ogni opera d’arte merita» (p. 211). Come dicevo, però, ciò non spinge Cavell a eliminare l’idea di una differenza qualitativa fra ciò che possiamo chiamare genericamente ‘buona’ e ‘cattiva’ arte anche nel caso del cinema (così come facciamo spesso nel caso della pittura, della poesia, della musica e della stessa filosofia, per differenziare i contributi di autori e autrici eminenti dalle opere meno riuscite o talvolta meramente ripetitive e standardizzate): «non tutti i film sono di fatto degni di tale attenzione», afferma infatti Cavell (p. 212), il quale si sofferma varie volte, non a caso, su categorie come ‘grandi registi’, ‘cinema serio’ e ‘film brillanti’ (pp. 227, 248), là dove questi ultimi sono quei film che «scoprono con la massima chiarezza e la massima profondità i poteri del medium stesso» (p. 248).
Prendendo le mosse da domande classiche come «Che cos’è l’arte?» o «Qual è l’importanza dell’arte?», nel primo capitolo del libro Cavell si chiede: «Perché il cinema è importante?» (p. 39) Da ciò ne scaturisce una riflessione, già accennata nella Prefazione e destinata poi a essere ripresa e approfondita varie volte nel corso del libro, sul rapporto fra il cinema e le altre arti – per esempio, allorché Cavell riflette sul fatto che «gli standard di rigore e di cultura che abbiamo imparato a dare per scontato [o a criticare] quando diamo o ci vengono date letture di libri, sono ignorati o inaccessibili quando diamo o ci vengono date letture di film» (p. 42), oppure là dove si sofferma sui rapporti fra cinema e teatro (pp. 65-66). Oltre a ciò, dalla succitata domanda iniziale scaturisce una riflessione su determinati tratti caratteristici e unici del cinema, come ad esempio il fatto che «tutti si interessano ai film», per cui «il cinema sembra esistere naturalmente in una condizione in cui i suoi esempi più alti e quelli più ordinari attirano lo stesso pubblico», laddove invece «le persone che si interessano alla musica seria non si interessano alla musica d’ambiente o, diciamo, alla musica da film» (p. 40) (sebbene si possa forse obiettare che tale situazione, riguardo alla musica, fosse probabilmente più usuale negli anni in cui Cavell lavorò alla stesura di Il mondo visto rispetto allo scenario musicale attuale, in cui alcune barriere fra stili e generi diversi sono state almeno in parte superate).
Ora, poiché «una nuova opera», secondo Cavell, «nasce, in una civiltà, dai poteri dell’arte stessa» (p. 42), e poiché la situazione artistica generale in cui nacque il cinema come forma d’arte fu la «condizione dell’arte modernista» (p. 45), a suo giudizio ne scaturisce logicamente il quesito su quale rapporto debba vigere fra cinema e modernismo. «Si dice spesso», osserva infatti Cavell, «che il film è l’arte moderna, quella a cui l’uomo moderno reagisce naturalmente», ma a suo giudizio sussistono diverse buone ragioni per «diffidare di questa idea», fra cui, primariamente, il fatto che, «se il cinema deve essere preso minimamente sul serio come forma d’arte, allora bisogna spiegare come possa aver evitato il destino del modernismo» (dato che, per Cavell, perlomeno per molti decenni è proprio questo ciò che è avvenuto): ovvero, bisogna spiegare come il cinema «possa aver mantenuto le sue continuità in termini di pubblico e di generi, come possa essere preso sul serio senza essersi assunto il peso della serietà. […] [I]l fatto ovvio del cinema», secondo Cavell, è infatti che, «se è arte, è l’unica arte tradizionale vivente, l’unica che può dare per scontata la sua tradizione» (p. 46). La questione del rapporto fra il cinema e il modernismo, posta nel primo capitolo del libro, sarà poi ripresa e sviluppata da Cavell innumerevoli volte nel corso di Il mondo visto (cfr. pp. 152-153; 169-171; 191-192; 245-248), sempre con l’aggiunta di nuovi stimoli e nuovi approfondimenti – ad esempio, in relazione a ciò che è avvenuto dagli anni Sessanta in poi, quando «il cinema si è gradualmente trasferito nell’ambiente modernista che le altre grandi arti hanno abitato per generazioni e dove ogni forma d’arte ha dovuto lottare per la propria sopravvivenza» (p. 111), oppure in relazione al grande tema del rapporto fra l’arte moderna e la poetica ottocentesca del realismo nelle sue varie forme (pp. 81, 232), che naturalmente non ha mancato di incidere anche sulla delineazione della peculiare estetica del cinema.
Nei capitoli immediatamente successivi Cavell introduce un altro tema fondamentale, se non proprio il tema fondamentale del libro, cioè quello del rapporto fra la realtà e la dimensione per così dire sui generis del mondo che viene dischiuso dai film. Il tema (estetico e, al contempo, rigorosamente epistemologico) del «fare i conti con la realtà» è già racchiuso nella domanda posta da Cavell nel primo capoverso del secondo capitolo: «che cosa succede alla realtà quando viene proiettata su uno schermo?» (p. 51). Per affrontare tale tema, Cavell si premura in primo luogo di definire il rapporto tra cinema e fotografia, evidenziando come quest’ultima, a differenza della pittura, «non ci presenta una ‘somiglianza’ delle cose», bensì «le cose stesse», e come, nonostante ciò, essa sia qualcosa che «non sappiamo come definir[e] ontologicamente», nella misura in cui, guardando una fotografia, «vediamo cose che non sono presenti» (pp. 51-52). A partire da qui, sottolineando come «le fotografie sono fotografie del mondo, della realtà nel suo insieme» (cosicché «quello che succede in una fotografia è che il mondo trova un termine»), Cavell sposta il focus della propria attenzione sul cinema e giunge alla definizione del film come «mondo [che] viene proiettato», in cui «lo schermo è una barriera» che «mi nasconde dal mondo che mi contiene – mi rende infatti invisibile. […] Che il mondo proiettato non esiste (ora)», scrive Cavell, «è la sua unica differenza dalla realtà» (p. 59). «La promessa del cinema», come si legge finanche negli ultimi capoversi di Il mondo visto, è quella di «esibire il mondo» e, come spiega Cavell, al fine di «soddisfare il desiderio di esibizione del mondo» si deve essere disposti a «lasciare apparire il mondo in quanto tale» (p. 205). Si tratta di ciò che Cavell, unendo in una maniera estremamente originale il registro filosofico dell’estetica con quello dell’epistemologia, definisce «il desiderio di totale intelligibilità» (p. 205); a tal proposito, dunque, risulta quanto mai affascinante notare come una fra le principali «possibilità del medium [cinematografico]», secondo Cavell, sia proprio quella di «lasciare che il mondo accada» (pp. 59-60).
La succitata questione relativa al «medium fisico del cinema in generale» viene collegata da Cavell a quella relativa «forme o ai generi specifici che questo medium ha assunto nel corso della sua storia» e alle «possibilità del medium», le quali, spiega Cavell, «non sono date», bensì si articolano e si dispiegano per l’appunto storicamente (p. 71). Così, Cavell si spinge ad argomentare come «le prime pellicole cinematografiche accettate come film» vadano intese in un certo senso come «la creazione di un medium per il fatto che questi film davano significato a delle possibilità specifiche. Solo l’arte stessa», scrive infatti Cavell, «può scoprire le sue possibilità, e la scoperta di una nuova possibilità è la scoperta di un nuovo medium», il quale può essere definito, a livello generale, come «qualcosa in cui, o per mezzo di cui, una cosa specifica viene fatta o detta in un modo particolare», nonché qualcosa che «fornisce delle modalità particolari per farsi capire da qualcuno, per essere comprensibile» (p. 72). Nel caso particolare del cinema, secondo Cavell, analizzare «le realtà concrete del medium cinematografico stesso» ci deve portare a riconoscere, ad esempio, che non sono tanto delle forme prestabilite e già date a veicolare l’espressione di determinati tipi, bensì «sono proprio i tipi a portare le forme su cui i film hanno fatto affidamento», là dove «il modo in cui i film creano degli individui» consiste nel fatto che essi «creano delle individualità» (p. 73).
Partendo da qui, oltre a sottolineare le differenze tra «un tipo nel cinema», in grado di realizzare «il mito della singolarità», e «un tipo nel teatro» (p. 74), Cavell mostra anche come la creazione di «cicli di film», lungi dal costituire un mero dato estrinseco o accidentale nella storia del cinema, rappresenti invece «una possibilità intrinseca di questo medium», nella misura in cui, a ben vedere, «un ciclo è un genere […] e un genere è un medium» (p. 75). A partire da tali premesse, quindi, si può facilmente comprendere l’enfasi e l’attenzione posta da Cavell, in alcuni capitoli importanti di Il mondo visto, su questioni quali i «miti del cinema» (pp. 87-89), i «tipi principali di personaggi» e i rapporti fra loro (pp. 95-99; 105-107), nonché le conseguenze dell’«esaurimento dei miti originari del cinema» (p. 180) che egli intravede nella storia del cinema col passare dei decenni. Questa concezione genuinamente relazionale, per così dire, dei nessi sussistenti fra la dimensione del «medium di un’arte» (l’arte cinematografica, in questo caso) e le dimensioni de «i generi, i tipi e le individualità che hanno costituito i media dei film» (p. 119) spinge Cavell, nel quinto capitolo di Il mondo visto, a citare un aspetto veramente centrale della sua filosofia del cinema: ovvero, il fatto che «con lo sviluppo di Hollywood i tipi originali si [siano] ramificati in individualità tanto diverse e sottili, tanto ampie nella loro capacità di influenzare i nostri umori e di liberare la fantasia, quanto ogni insieme di personaggi che popolavano i grandi teatri del nostro mondo. […] Hollywood è stato il teatro in cui sono apparsi» determinati tipi, singolari e unici, perché «i film di Hollywood hanno costituito un mondo» (p. 75), laddove, come si legge nel dodicesimo capitolo, in maniera piuttosto drastica Cavell decreta che «la Nuova Hollywood non è un mondo» (p. 128). È, quest’ultimo, uno degli aspetti dell’indagine sviluppata in Il mondo visto in cui il piano dell’analisi filosofica e il piano dell’esperienza personale di fruizione cinematografica (con tutto il carico di soggettività e talvolta idiosincrasia che tale esperienza inevitabilmente comporta) si saldano e si intrecciano l’uno all’altro nella maniera più stretta, per non dire inscindibile. Nel saggio conclusivo «Ancora su Il mondo visto», a tal proposito, Cavell ammetterà con grande onestà di essersi limitato, «come [suo] canone di riferimento, ai soli film sonori che avev[a] a disposizione mentre scrivev[a]» e riconoscerà che la sua «eccessiva indulgenza verso i contributi di Hollywood alla storia del cinema», da un lato, e la sua «quasi totale omissione del cinema sperimentale contemporaneo» (p. 214), dall’altro lato, potrebbero anche suscitare qualche diffidenza.
Oltre a ciò, nel corso di Il mondo visto Cavell non manca di soffermarsi con lucidità filosofica e, al contempo, con genuina passione cinematografica su molti altri argomenti, fra cui il rapporto fra il bianco e nero ed il colore (pp. 133-146), la dimensione dell’automatismo dei dispositivi tecnici e l’«implicazione della cinepresa» (pp. 177-179), se non proprio il «destino della cinepresa» e l’«interesse mitologico delle rivelazioni della cinepresa» (p. 225), alcune tecniche cinematografiche come il rallentatore, il flashback, il fermo immagine e lo schermo diviso (pp. 185-191), la relazione fra il suono e il silenzio o il rapporto fra spazio, tempo e azione nel cinema (pp. 197-204). In ogni caso, la molteplicità dei temi affrontati in Il mondo visto (e, quindi, la notevole versatilità della riflessione cavelliana sul cinema) non contrasta affatto con la grande unitarietà e coerenza di tale riflessione, garantita dal rigore con cui Cavell pone e ripropone quella che, sia su un piano strettamente estetico sia su un piano epistemologico, gli appare la questione decisiva e centrale della filosofia del cinema: ovvero, la succitata questione relativa al fatto che «il cinema [sa] riprodurre magicamente il mondo» ed è in grado di farlo «[n]on presentandoci letteralmente il mondo, ma permettendoci di guardarlo senza essere visti. […] [S]iamo dislocati, esiliati dalla nostra dimora naturale nel mondo, posti a una distanza dal mondo» (pp. 82-83). «Il cinema», scrive Cavell, «ci restituisce ed estende la nostra prima fascinazione per gli oggetti, per le loro vite interiori e determinate» (p. 88); esso «soddisfa il nostro desiderio di una riproduzione magica del mondo, permettendoci di vederlo senza essere visti. Ciò che desideriamo vedere in questo modo è il mondo stesso – in altre parole: tutto» (p. 151). Se è vero che «ogni arte vuole l’espressione del mondo» (p. 199), allora il cinema, per Cavell, «promette l’esibizione del mondo in se stesso» (p. 169).
Anche nel saggio conclusivo «Ancora su Il mondo visto» Cavell ribadire con grande enfasi che «ciò che rende il medium fisico del cinema diverso da qualsiasi altra cosa sulla terra consiste nell’assenza di ciò che esso ci fa apparire dinanzi: vale a dire nella natura della nostra assenza da esso” e nel suo offrire una seria di «proiezioni della realtà in cui […] la realtà è lasciata libera di esibirsi» (p. 213). Per Cavell, infatti, «il modo in cui il cinema presenta a noi il mondo astraendoci da esso risulta essere una conferma di qualcosa che è già vero dello stadio dell’esistenza in cui ci troviamo», nel senso che il «dislocamento del mondo» che viene prodotto dal cinema «conferma […] il nostro preesistente estraniamento dal mondo. La ‘sensazione di realtà’ che il cinema fornisce è la sensazione di […] una realtà nei confronti della quale sentiamo già una certa distanza» (p. 252). Sotto questo punto di vista, per Cavell si può persino parlare, in maniera estremamente ambiziosa, di un vero e proprio «mistero epistemologico» del cinema (p. 226), nella misura in cui «la base della drammaticità del cinema […] risiede nel suo dimostrare persistentemente su che cosa si fondi la nostra certezza della realtà», ovvero nel suo dimostrare il carattere mediato (ma non per questo illusorio o fittizio) del nostro rapporto col mondo.
Mettendo la realtà sullo schermo, il cinema fa da schermo tra noi e la datità della realtà: tiene la realtà lontana da noi, la tiene davanti a noi, in altre parole la trattiene davanti a noi.
(p. 228)
Diversi decenni fa, a proposito della filosofia della musica di Theodor W. Adorno, Luigi Rognoni osservò a ragione che essa parlava «al filosofo in termini musicali e al musicista in termini filosofici, in una piena e acuta compartecipazione tecnica fra i due campi». Mutatis mutandis, nonostante le differenze in termini di background culturale e approccio filosofico tra Adorno e Cavell (e nonostante il fatto che, com’è noto, Adorno purtroppo non amasse il cinema e, in generale, tutta la popular culture…), forse si può sostenere che qualcosa di analogo possa valere anche nel caso di Cavell, nel senso della sua capacità di fornire suggestioni egualmente stimolanti sia ai filosofi che agli studiosi di cinema, «in una piena e acuta compartecipazione tecnica fra i due campi» (per riprendere l’efficace formula coniata a suo tempo da Rognoni per la «musicologia filosofica» di Adorno). Come scrive Donatelli all’inizio del suo saggio introduttivo, Il mondo visto di Cavell è infatti «un libro affascinante, denso ed enigmatico», in cui il cinema viene interpretato filosoficamente come «un fatto dell’esperienza che ci riconduce alla dimensione esistenziale primordiale di individui spaesati di fronte al mondo che ci scorre davanti» (p. 9). Gli fa eco Manzoli, nella succitata Postfazione al libro, là dove osserva che Cavell, vero e proprio «filosofo in sala», prende le mosse dalla propria «esperienza di spettatore cinematografico» e, sulla base delle categorie centrali del proprio pensiero (e, in particolare, sulla base di quelle che Manzoli definisce «le due grandi ossessioni del volume: il tema del realismo, definito come l’attitudine a ‘fare i conti con la realtà’ e quello della natura di questa realtà depurata dal peso dell’ego, rivelatoria e capace di attivare l’io per offrirgli gli elementi con cui costruire un nuovo rapporto col mondo»), arriva a offrire «un grande esercizio di intelligenza spettatoriale che prende le mosse da una passione sconfinata nei confronti dei film e da un rispetto profondo per la funzione esistenziale e intellettuale di quest’arte» (pp. 259-262).
Collegamenti